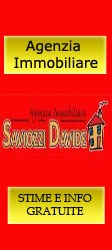Un paese che amo, il paese della mia mamma.Anche ora quando vado a RIPAFRATTA sono la figlia della "Cocca".
Un paese con una storia importante che conserva vestigia di grande rilievo.
Un paese rimasto inalterato nel tempo, non ci sono insediamenti nuovi, potrebbe essere il set di film d'epoca perché anche le case, le facciate conservano la patina del tempo.Un paese che è ancora comunità.













-
Gentili ospiti di Lilli Gruber [1]
-
Oggi Pesce? No! Rondine d’aprile. [1]
-
P D nel caos: il padre di Elly Schlein la smentisce sul Medio Oriente – “Mia figlia non capisce nulla” [2]
-
Dunque, voglio raccontarvi una storia... [4]
-
Come superare un lutto? [3]
-
NEL FRATTEMPO MELONI… [1]
-
Cristiano Meciani risponde a Carlo Cavalletti [5]

di Valdo Mori



di Valdo Mori









cambiano i volti belli
ma i tuoi occhi sono rimasti
quelli di allora
ed è nei tuoi occhi che vedo
l'amore che non è mutato
e .....



-
Jannik Sinner ha sbalordito il mondo intero rifiutando l’offerta da 10 milioni di dollari di Elon Musk [593]
-
SABBIODOTTO PER IL PORTO DI VIAREGGIO. I SEDIMENTI SIANO UTILIZZATI ANCHE PER IL RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE... [225]
-
ALBERTO FREMURA - 3° incontro [173]
-
Come superare un lutto? [153]
-
Ultimo appuntamento del "Marzo delle Donne" con Giusi D'Urso [147]
-
LITORALE: DALLO STUDIO DI UNIPI UNA NUOVA SOLLECITAZIONE AD UN DECISO CAMBIO DI ROTTA. [136]
-
Il bellissimo Cecé al Fortino [130]
-
Verde Pisa 2025: più che una mostra, un’esperienza! Per chi la natura l’ama e non si limita a guardarla. [120]
-
IL MIGLIARINO/VECCHIANO RITORNA ALLA VITTORIA, DEVE MANTENERE CONTINUITA' NEI RISULTATI. FILETTOLE KO IN CASA [117]
-
Una finta eclisse per un’eclisse eclissata. [115]
-
contro mastro ciliegia Fumus che puzza su Picierno [113]
-
*Il filo dell’amore, un filo che unisce!* (vedi pdf allegato) [112]
-
POMERIGGIO BENESSERE [106]
-
Sestosenso trionfa a Lione: l’amaro di Calci conquista l’oro internazionale [106]
-
Oggi Pesce? No! Rondine d’aprile. [104]
di Alessio Niccolai

È scorrendo un paio di giorni fa il Forum e, in particolare, leggendo il “documentatissimo” intervento di «Chiara» in favore dei SI-TAV che ho deciso che questo mio contributo, anziché un post qualunque sarebbe stato un articolo, con la complicità della redazione de “La Voce”.
Ho ritenuto necessario non disperdere questa dissertazione tra le migliaia di parole in libertà del Forum, fondamentalmente per rendere onore filosofico al «metodo», lasciando per una volta che il «merito» rimanesse in background, o, come si direbbe nella Val di Serchio «in se’ondo piano».
«Chiara» ha apostrofato noialtri NO-TAV con parole argute, parafrasando De André, degne di un intelletto mediamente superiore a quello dei vari «Tito», «Luigi», «Ultimo», «Primo» e così via, ben lontane dai rituali piagnistei sul transatlantico-Ikea ormai salpato e abbondantemente al largo sulla sua rotta errabonda, memore delle gesta del leggendario Olandese Volante, portatore di sventura e condannato per l’eternità a vincere a dadi il sei contro tutti gli altri numeri, i piagnistei profferiti a turno quando da un mai arrendevole, seppur grottesco e quasi caricaturale Alessandro Ghelardi, quando da un Graziano Pardini ormai pronto, nella sua deriva fra i flutti di una politica locale ingrata, a ghermire la «magia del fantasy», quella stessa che trasforma in una sorta di atavica concezione manichea il buono in cattivo, il possessore dello strumento magico in dominio inconsapevole dello stesso, mutandone le originarie umane fattezze in qualcosa di impronunciabile, quando ancora dalla nickname di turno che tante volte mi sono chiesto quando non nascondesse uno dei due.
Ma «Chiara» è ed è sempre stata una cosa molto diversa, una specie di tenero virgulto nato e cresciuto forse nel terreno sbagliato, distinguendosi molto spesso per una dote poco comune sul Forum, cioè per la non comune capacità di argomentare le proprie teorie, ancorché decisamente diverse dalle mie.
Questo strano e desueto modus operandi che fa di «Chiara» un potenziale essere illuminato in erba, è quella strana, devastante ed incontenibile scintilla che anima - o almeno nella maggior parte degli esseri umani dovrebbe animare - la ricerca incessante del sapere e della verità.
La verità è un essere animato, dotato di un’esistenza - oserei dire - parallela, impalpabile e inebriante al solo pensiero di essere colta, non fosse altro che, ahimè, quando ad un essere umano è dato di coglierla già «non è più»: sì, perché la verità è un qualcosa di sterminatamente onnicomprensivo, la gigantografia di un qualcosa inverosimilmente sconfinato nel tempo e nello spazio che per ironia della sorte nel momento in cui si rende disponibile e immanente, denuncia l’aver cessato di essere; il suo perenne divenire ne fa un oggetto conoscibile soltanto quando è scorsa e il suo eterno peregrinare proiettato verso l’avvenire ne sancisce l’inconciliabile e riluttante percettibilità al presente.
Ciò non vuol dire nient’altro se non che l’unica e possibile verità è la storia, finanche di un secondo prima se il suo analista è abbastanza bravo da mettere insieme milioni di informazioni provenienti dal globo intero in maniera pressoché istantanea e trarne una verosimile sintesi.
L’etereo e insondabile mondo delle tre “W” ha poderosamente accorciato le distanze spazio-temporali e in un futuro abbastanza prossimo imprimerà a tale conclamata tendenza una forza capace di assottigliarla ulteriormente secondo uno schema infinitesimale: eppure come nel più famoso dei Paradossi di Zenone, il Paradosso di Achille e la Tartaruga, la verità beffarda rifugge l’immediatezza della sua immanenza e conoscibilità, incarnando la proverbiale lentezza dell’anapside che il lesto figlio del sovrano mirmidone Peleo e della nereide Teti non riuscì mai a superare, immemore della convinta e convincente confutazione che Diogene di Sinope e Aristotele di contro addussero.
Così la sola auto-elevazione, il proprio indefesso e irredento protendere al sapere che è di per sé storia, storia fatta di narrazioni, di narrazioni di narrazioni, di narrazioni di narrazioni di narrazioni, etc. circolanti libere e orgogliosamente disordinate, organizzate secondo un apparente moto casuale in tutto e per tutto simile al flusso sinaptico, secondo un moto browniano o almeno una sua incomprensibile sembianza che in qualche modo è incline a ricomporre una verità, una fra le tante che assemblano quella complessiva, la storia, secondo un disegno che all’uomo non è dato conoscere se non a posteriori, possono essere considerate uniche fonti attendibili.
La verità è mutevole e lo è senza soluzione di continuità: i padri delle tre principali religioni monoteiste provarono a suo tempo a rallentarne il decorso, finanche a far girare il mondo nello stesso suo senso e alla sua stessa velocità, purché la si potesse avvertire come immota, eterna e immutabile; eppure la verità seppe farsi beffa anche della loro pretesa parentela con l’Altissimo, seppe schernire i loro clerici, i loro profeti, i loro santi e i loro martiri ben prima che le moderne scienze trovassero una valida ragione per demolirne con un intercedere inspiegabilmente indolente e torpido le malsane fondamenta.
E mentre claudicanti e becere figure togate tentarono di portare a compimento il loro fallace piano di imprigionare la verità, di incatenarla a dogmi che intesero dipingere come imperituri, definitivi ed inestinguibili, essa sfuggì loro tra i più acri e caustici miasmi di carne arsa sui roghi, fra grida di paura e strazio, fra rivoli di sangue che si fecero torrenti e poi fiumi confluenti in un oceano di nulla e morte, essa ancora si sottrasse alle loro malevole attenzioni per abbracciare la mente di figuri ipogei, sfuggevoli come gli Elfi o le Fate nelle saghe di Tír na nÓg, irridenti delle terribili privazioni materiali che fuori dalle proprie ristrette cerchie la follia dilagante imponeva al restante genere umano: furono quelli tempi in cui la storia dovette essere studiata come una disciplina catacombale, nemica di quella insulsa verità immota e senza tempo che gli insipidi postulanti degli Altissimi cercarono di contrapporgli.
Ma non è di tempi remoti che intendo trattare in questo mio scritto, se non per dimostrare che la verità, attraverso il suo più indomito strumento, la storia, sfugge inesorabilmente chiunque voglia possederla, trattenerla o pretenderne l’assolutezza.
I Cercatori della verità, come l’impavido Richard Rahl nella Spada della Verità di Terry Goodkind, come Allanon, il Druido nelle saghe di Shannara di Terry Brooks o ancora lo stregone Gandalf di John Ronald Tolkien ne “Il Signore degli Anelli” sono esseri perennemente votati al movimento, all’inseguimento di un qualcosa di ineffabile che ogni tappa si rivela - a loro per primi - quando ormai ha già avuto luogo e ha cessato di divenire, e il loro compito letterario è quello di prenderne inesorabilmente atto per poterla cambiare, mutare secondo le migliori e più nobili intenzioni che l’umanità possa auspicare; ciò nondimeno, se anche un destino errabondo e cavalleresco li ha eletti primi e migliori conoscitori della sua inenarrabile consistenza, nessun potere magico, nessun talismano, nessuna pozione li metterà mai nella condizione di sovrastarla, superarla o afferrarla prima che i suoi più soverchianti effetti si siano sopiti o esauriti del tutto.
Ad uno scriba o ad un cantastorie di nobile lignaggio è dato invece di narrarne le vicende, consegnate dagli stessi Cercatori alla sua penna o alla sua bocca, ormai molto tempo dopo che essa è entrata - come frammento di storia - a far parte del dominio della loro conoscenza insaziabile.
C’è in tutto questo qualcosa di arcano e sfuggevole però: chi e cosa sono i Cercatori? Che cosa assicura loro di aver colto della verità ogni sfaccettatura, ogni più profonda implicazione, cosa li rassicura del fatto che di pulviscolo di verità si tratti da riversare nella raccolta di precedenti confratelli frammenti, e non di un’illusoria visione, di una edulcorata o avariata percezione, di una ricostruzione deteriore e fallace?!?
La risposta va necessariamente cercata fuori dal fantasy e dalla letteratura, rintracciata nel quieto alveo della filosofia, strumento cognitivo della storia, dunque altro eminente suddito della verità, ancorché mutevole nell’umore e sua manifestazione speculare.
La filosofia ha il preciso compito di ricostruire sistematicamente le leggi che regolano la ricerca della verità, il modo stesso di ricercarla, o per meglio dire, il metodo: chi può stabilire quale sia il metodo attraverso cui la verità appena trascorsa si rende conoscibile nel modo più esaustivo, si divarica secondo l’angolo più aperto e si snoda più verosimilmente?
Il metodo è sostanzialmente la fissazione di una scaletta di priorità, assolutamente parametrica, dunque vettoriale, sulla base della quale leggere e interpretare la verità, dunque formulare la teoria storica.
L’essere umano è forgiato e temprato dall’esperienza e dalle convinzioni maturate per eterogenesi dei fini, per convenienza o opportunità (assolutamente materiali) cui è approdato, dalla quantità di volte che è riuscito a cogliere il suo misero barlume di verità, e si relaziona all’intero processo storico come se niente esclusa la sua soggettività gli potesse sfuggire: ed è proprio per questo che la sua ricerca si rivela fallace il più delle volte rendendolo la cosa più lontana dall’archetipo di Cercatore della Verità.
La fissazione di un metodo di indagine è una sorta di patrimonio genetico della persona, un suo preciso tratto distintivo e non rappresenta di per sé un’operazione neutrale, ne’ conseguita in una sola volta, in ogni caso soggetta a logoramento o addirittura a soccombere quando la forbice e lo scollamento tra le conclusioni a cui generalmente conduce e la verità, dunque la storia si faccia incolmabile.
La ricerca storica per certi versi deve somigliare all’analisi matematica, per altri alla ricostruzione attendibile di un modello (che non necessariamente deve corrispondere ad una qualche realtà soggettiva), per altri ancora ad una sorta di indagine poliziesca in cui il bravo l’investigatore abbia la capacità di discernere il preconcetto iniziale dal punto in cui lo abbiano pilotato le prove.
Ed è esattamente qui che possiamo tornare alla vicenda argomentativa di «Chiara»: ogni investigatore che si rispetti inizia la sua indagine con un preconcetto sospetto, convinto della validità della falsa pista verso la quale l’istinto lo ha condotto, premurosamente confusa con la verità conoscibile al presente; ma via via che gli si disvela, suo malgrado, è costretto ad accettarne la cruda e brutale consistenza, dunque a ricavarne le uniche e inizialmente non auspicate conclusioni.
Non è un mistero che a governare e ad indirizzare la costruzione del nostro soggettivo impianto probatorio sia una preconcetta e quasi fideistica adesione ad un preciso sistema filosofico: così, come senz’altro il sottoscritto, Simone Cioli e Dario Focardi hanno cercato argomentazioni a suffragio della teoria NO-TAV, animati da un’innata simpatia, da un’omogeneità ed una contiguità - potremmo dire - ideologica con gli abitanti della Val di Susa contrari al progetto, in ugual misura «Chiara» è andata metodicamente a ricercarsi una documentazione che sostenesse le tesi SI-TAV; il fondamento di entrambe le prese di posizione è, almeno in apparenza, coerente con una presa di posizione a priori, dalla quale sono dipese e dipendono tutte le conseguenze logiche e le conclusioni.
A questo punto però diventa primario compiere uno studio attento intorno a quale possa essere l’approccio metodologico degli uni, quale quello degli altri, dunque, muoversi certosinamente nella ricostruzione delle scalette di priorità che ciascuno ha formulato rispetto al rendersi immanente della verità, dunque alle modalità di ricostruzione storica.
L’Oggettività è l’impianto metodologico che riesce a soddisfare al maggior numero di condizioni di ricerca, a disvelare il maggior numero di enigmi, a risolvere la maggior quantità di contraddizioni e contraddittori, a dare risposte soddisfacenti ed è solitamente la conditio sine qua non in ragione della quale si scatena «l’abolizione dello stato di cose presente», l’antesignano dell’istanza di cambiamento, perché unicamente laddove la realtà sia conosciuta a fondo e/o nella sua interezza, dunque si approssimi alla più corretta percezione della verità - qualunque essa sia - si innesca il motore inarrestabile del cambiamento.
Si pensi ad un banale mal di stomaco: finché non si sarà accettato il fatto che insiste dolorosamente su un proprio momentaneo stato di salute, non si prenderanno le necessarie contromisure per combatterlo.
Il leggendario «Iosce», “Mario d’Avine” lo sintetizzava causticamente e sarcasticamente nel lapidario detto: «O pprova a ddi’ ch’è cotto anco s’è crudo!», ma in questa trattazione ho la necessità di sviscerarlo molto più a fondo.
Ora, insistono nella formulazione della scala di priorità metodologiche una serie infinita di parametri che ciascuno dispone davanti o dietro a secondo della propria educazione, del contesto familiare in cui è cresciuto, dei condizionamenti religiosi, del proprio approccio alla sessualità, delle proprie frustrazioni, etc., ma soprattutto delle proprie condizioni materiali di esistenza, sancite generalmente non dalle capacità o dal merito, ma dalla trasmissione verticale della proprietà privata per via ereditaria, dal casuale trovarsi nel posto giusto al momento giusto, o dallo spostamento orizzontale della proprietà privata o sue parti cospicue, indipendentemente dalla volontà del suo trasferente o del suo beneficiario.
L’Oggettività, per effetto di un condizionamento ottimamente riassunto nel detto «chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che perde ma non quello che trova», non riesce a far breccia nell’immaginario dei più e, paradossalmente e incredibilmente, ciò avviene più evidentemente presso il ceto medio o le aristocrazie operaie che presso altre classi sociali: se il cambiamento deve mettere in discussione le miserevoli certezze «costruite con la fatica e con il sudore», perché è anche su quelle che si consuma il contraddittorio disegno del sistema politico-sociale, diviene imperativo categorico - in particolare per questo segmento della società civile - rifiutarne ogni possibile implicazione e «con tutto il fiato in gola».
Questa preconcetta dipendenza è cagione di tutti i successivi e più perniciosi guasti intellettivi: la via più semplice per non rischiare di dover evocare lo spettro del cambiamento e dell’evoluzione, è un artificio, una suggestione della mente che volge subitaneamente all’occultamento della realtà, quindi ad impedire una corretta ed esaustiva percezione di quella che può essere la verità, dunque la storia.
E l’artificio si consuma o, per meglio dire, si compone di un banalissimo costrutto: l’impietoso rimescolamento delle carte nella formulazione della scala di priorità metodologiche; è sufficiente invertire o cancellare qualche fondamentale parametro per scongiurare la possibilità di dover accettare la realtà quale effettivamente è, dunque di dover far propria l’istanza di cambiamento.
L’indagine primaria della realtà passa innanzitutto, in un accesso propedeutico alla metodologia, per la comprensione del livello di interazione di ciascun individuo con il resto della sua collettività, di essa con i contenitori più grandi fino a giungere a quello o quelli che li contengono tutti quanti.
Immaginare ad esempio Vecchiano come realtà indipendente dagli avvenimenti mediorientali o latino-americani è una semplificazione che non ricostruisce un modello attendibile di realtà, dunque una rappresentazione fallace della verità.
Per far ciò è sufficiente ad esempio immaginare che le leggi nazionali non sortiscano alcun effetto sull’amministrazione del territorio, o che una fra le tante priorità da immettere nella scala metodologica, ad esempio l’occupazione debba salire al primo posto, quando la realtà stessa ne denuncerebbe un sostanziale sovradimensionamento.
Come si può o si deve formulare allora la scala delle priorità metodologiche per conseguire un risultato che soddisfi pienamente alle condizioni più elementari di Oggettività: il primo e più ragionevole dei parametri deve essere necessariamente il principio per cui «ciascun cambiamento introdotto non deve pregiudicare irreversibilmente le scelte future, non condizionare negativamente il presente e non vanificare le scelte (valide?) passate».
Siamo però di fronte al primo problema: cosa sancisce la validità di una scelta compiuta nel passato? Essenzialmente il fatto che a suo tempo non abbia condizionato l’allora presente e non abbia pregiudicato il futuro a sua volta, ma qui entra in gioco un elemento nuovo, a questo punto irrinunciabile, un elemento meramente quantitativo: la validità di una scelta (quindi di un’azione) si può misurare semplicemente sulla base di quanto e quale benessere ha riversato sulla società civile nel suo insieme e non presso qualche isolato suo esemplare, inducendo per giunta disagio o contraddizioni sugli altri restanti; per un vezzo nominalista chiamerò d’ora in avanti questo approccio metodologico «teoria del maggior bene comune».
Laddove non possa essere affermata la «teoria del maggior bene comune», possiamo adottare per assurdo «la teoria del male minore», ovvero, il ribaltamento delle risposte ai dilemmi (o paradossi) rituali delle donne incinte o delle neo-mamme in allattamento: è giusto per una donna in stato interessante fare una radiografia per una sospetta frattura, o una amniocentesi per verificare lo stato di salute del nascituro? Oppure, è giusto o meno curare una mastite in allattamento con gli antibiotici?
Le risposte sono in questo caso paradigmi e non hanno nulla a che vedere con la morale cristiana: è scontato cioè che la gestante o la neo-mamma abbiano già compiuto la propria scelta etico-morale a tempo debito.
Fare o non fare una radiografia in ragione di una sospetta frattura significa per una gestante chiedersi quale impatto i raggi x potranno avere sul nascituro: le possibili soluzioni sono molteplici e la scelta è volente o nolente una responsabilità da doversi prendere.
Nel caso ad esempio di una sospetta frattura ad uno dei piedi, l’irradiamento non avverrà direttamente sugli “alloggi del bambino”, benché la circolazione sanguigna dell’area “bombardata” dai raggi x possa senza ombra di dubbio recare plasma irradiato verso l’embrione/feto; occorrendo che il dolore arrecato sia insopportabile a tal punto da far ponderare l’idea di assumere anti-dolorifici, magari fino alla piena maturazione del nascituro, il cosiddetto «male minore» può risultare la radiografia, ma se essa dovesse rivelare che effettivamente di frattura si tratta, a seconda della tipologia di danno può essere opportuna l’applicazione di un gesso o addirittura un intervento chirurgico; questa seconda possibilità genererebbe inevitabilmente nuovi inquietanti interrogativi.
Il dilemma dell’amniocentesi è meno diffuso e talvolta l’operazione diagnostica viene somministrata alla gestante con la massima tranquillità, in ragione del fatto che non sempre le sono chiari i fattori di rischio connessi a questo genere di utilizzo della diagnosi preventiva; è ragionevole pensare in ogni caso che, laddove non esista una casistica familiare conclamata di aberrazione genetica, disfunzione o affini, i fattori di rischio siano troppo elevati perché valga veramente la pena sottoporsi a questo genere di indagine.
Il paradosso della neo-mamma in allattamento vittima di un’occasionale mastite, accompagnata magari da uno stato di febbre con temperature molto elevate, riesce ad essere in qualche modo ancora più emblematico: non attaccare al seno il lattante equivale a disturbarne poderosamente abitudini e quiete, mentre cedere al suo inevitabile pianto può equivalere a nutrirlo con un latte di qualità deteriore, magari impoverito da un punto di vista nutrizionale e a più probabilmente alta carica batterica.
Se il problema avesse una soluzione molto rapida, nell’ordine cioè di qualche ora, sarebbe anche estremamente più semplice dare una soluzione al dilemma postosi; ma se il decorso della patologia - a cose normali facilmente trattabile - producesse una sintomatologia protratta, come generalmente accade, per due o tre giorni, si innescherebbe inesorabile il meccanismo di un ulteriore dilemma in cascata: la produzione di latte materno è condizionata dal fatto che il neonato se ne nutra e, come ogni madre in allattamento ben sa, venendo meno il regolare consumo lo stimolo produttivo si esaurisce anche piuttosto repentinamente, peraltro cosciente che l’ausilio del tiralatte non le restituisca garanzie a lunga gittata.
La perdita del latte materno, nel caso di un lattante che se ne nutra e che ne ricavi tutto l’apporto nutritivo necessario alla propria sopravvivenza, ingenera una serie notevole di complicazioni e difficoltà: la prima è quella di abituare il lattante a nutrirsi con il latte artificiale che, ancorché psicologicamente traumatica per madre e figlio al contempo, inizia a essere un ostacolo di non poco conto; la seconda è quella invece di assestare un aggravio economico notevole sul bilancio familiare.
Questa consapevolezza, nel caso di insorgenza di una mastite, deprime il morale della madre, riducendo ulteriormente i margini per una guarigione rapida.
Ma il ricorso a questo approccio metodologico non nelle scelte soggettive, ma in quelle inerenti la propria strategia di conseguimento del bene collettivo, dipende quasi sempre da una precedente cattiva applicazione della «teoria del maggior bene comune», ovvero da una scelta o una sequenza orizzontale e/o verticale di scelte (cambiamenti) cha ha pregiudicato irreversibilmente le scelte successive, e condizionato negativamente quelle presenti.
Diventa a questo punto essenziale l’esatta comprensione di ciò che si deve intendere per «teoria del maggior bene comune», perché essa stessa è frutto di una visione prospettica delle cose, dunque, almeno sulla carta, vincolata ad una sua scaletta intrinseca di priorità che la subordina in qualche modo alle leggi dell’arbitrarietà: l’identificazione del «maggior bene comune» non è affare semplice, ma la sua collocazione nel processo storico può darle un conforto pressoché risolutivo.
Osservando che il «bene comune» dall’antichità ad oggi si è quasi sempre legittimato nell’opera emancipatrice delle classi sociali dominate che hanno scardinato e deposto l’anteposto «bene privato» o «bene limitato», nonché il dominio della classe sociale che ne era stata fautrice e sostenitrice, potremmo a buon diritto affermare che quanto più si estende il dominio numerico sulle risorse, tanto maggiore è il «bene comune».
Ciò, per analogia, dovrebbe significare che il prossimo passaggio epocale, quello che a cose normali può essere considerato una rivoluzione, dovrà ingenerare una sostanziale estensione delle possibilità di accesso alle risorse, dunque, in buona sostanza ridurre drasticamente - se non addirittura abolire - la quantità e le dimensione dei «beni privati» o dei «beni limitati».
Se consideriamo la fantomatica «legge dell’80/20», la legge per cui il 20% della popolazione mondiale detiene l’80% delle risorse, mentre l’80% di essa se ne ripartisce il 20%, non dovremmo avere difficoltà a comprendere che la spinta progressista, che le borghesie nazionali con le tante rivoluzioni mediante le quali hanno spodestato l’aristocrazia, l’Ancient Régime, introducendo grandi innovazioni sociali, epocali allargamenti della partecipazione alla vita politica, si è ormai irreversibilmente esaurita in questo approccio conflittualmente internazionalista all’economia e alla politica che è rappresentato dall’incarnazione finanziaria del modo di produzione capitalistico.
Tutte le argomentazioni che protendano a mantenere in vita un sistema ormai logoro e consunto, ancorché di ispirazione e aspirazione diversa e sempre più spesso contrapposta, non fanno altro che ampliare lo spettro delle contraddizioni sociali, indebolire il ceto medio, caposaldo del binomio capitalismo/democrazia classica occidentale, allargando irreparabilmente la forbice fra ricchi e poveri del mondo.
L’unica rivoluzione pacifica auspicabile che il mondo possa invocare a questo punto, passa per l’auto-riduzione dei profitti che è l’anticamera dell’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, una sorta di quieto passaggio di testimone del dominio da una classe sociale ad un’altra, secondo il principio storicamente consolidato dell’ampliamento numerico della partecipazione politica e dell’accesso alle risorse; in altre parole la borghesia dovrebbe a questo punto essere pronta ad abdicare a sé stessa, lasciando al proletariato il compito di instaurare un nuovo pactum societatis fra gli uomini, memore di un’operazione compiuta a proprio beneficio dalla soppressa (purtroppo non del tutto, perché ricordiamoci che la borghesia in più di 600 anni di dominio non ha saputo neanche mettere la parola fine sull’Ancient Régime, emulandone anzi alcuni comportamenti e prerogative con la creazione di forme di rendita come quelle finanziarie o immobiliari) aristocrazia, suo antico avversario sociale.
In alternativa è preciso compito delle avanguardie comuniste ricostituirsi, imporre la propria contiguità e presenza ai movimenti di rivendicazione e indirizzarne l’operato inesorabilmente, implacabilmente verso l’alba di una nuova era.
Ma questa è tutt’altra storia e non riguarda precipuamente questa trattazione: ciò che invece è decisamente centrale, è l’individuazione puntuale della scaletta delle priorità per la definizione di un approccio metodologico realmente oggettivo, ovvero quanto comunemente si può desumere riepilogativo del principio per cui «ciascun cambiamento introdotto non deve pregiudicare irreversibilmente le scelte future, non condizionare negativamente il presente e non vanificare le scelte passate».
Lo si chiama comunemente «sviluppo sostenibile», una curiosa rielaborazione interclassista adottata a cuor leggero dai partiti progressisti (e borghesi) d’Occidente (in ragione di un approccio opportunistico) di un insieme di istanze tanto care - una per volta o a gruppi - ad una moltitudine di movimenti di rivendicazione:
Sostenibilità Economica, ovvero la capacità di generare HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito" reddito e HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro" lavoro per il sostentamento della HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione" popolazione;
Sostenibilità Sociale, cioè la capacità di garantire condizioni di HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Benessere" benessere umano (sicurezza, HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Salute" salute, istruzione) equamente distribuite per classi e genere;
Sostenibilità Ambientale, ovvero la capacità di mantenere HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0" qualità e HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Riproducibilit%C3%A0" riproducibilità delle HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_naturali" risorse naturali;
Sostenibilità Istituzionale, cioè la capacità di assicurare condizioni di HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A0" stabilità, HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia" democrazia, partecipazione, HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia" giustizia.
Questo modulo di crescita armoniosa non è in realtà minimamente conciliabile con le leggi del modo di produzione capitalistico, e nessuna rivendicazione efficace potrà condurne vittoriosamente le sorti, nessuna mobilitazione ne potrà saldamente e responsabilmente assumere la direzione, se prima non si saranno politicamente rimosse le condizioni che ne compromettono l’intercedere, ovvero gli odierni rapporti sociali fondati sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sulla democrazia classica occidentale che ne incarna la rappresentazione politica più avanzata.
Ma ancorché inconciliabile con le necessità produttive e con le leggi del profitto, questo modulo rappresenta pur sempre una coraggiosa piattaforma metodologica perché, almeno in linea di principio, rispettosa del principio di cui sopra.
Una rivendicazione che risponda correttamente alla «teoria del maggior bene comune» è sicuramente argomentata e motivata da questo approccio metodologico: sicuramente lo è quella dei comitati NO-TAV della Val di Susa.
Il pretesto dell’occupazione è uno spauracchio che gli agenti della borghesia, hanno iniziato ad agitare costantemente e senza soluzione di continuità da quando hanno avvertito i primi scricchiolii e le prime vacillazioni del modo di produzione capitalistico: l’argomento fa enormemente presa sul ceto medio in evidente via di proletarizzazione; ma si tratta pur sempre di un artificio dissuasorio, pervicacemente indirizzato alla difesa di interessi di parte e al mantenimento in vita di un’aristocrazia operaia che rappresenta ormai la più acuta sintomatologia dell’agonia capitalistica.
I comitati NO-TAV della Val di Susa rappresentano essi stessi istanze centrifughe di quello stesso ceto medio in via di proletarizzazione che altrove risponde con un corteggiamento parossistico dell’antico alleato, la grande borghesia capitalistica, alle brutali sollecitazione cui il mercato lo sta sottoponendo: l’approccio metodologico impartito dall’idea di «sviluppo sostenibile», ancorché non del tutto o non ancora improntato ad una concezione internazionalista, ha il pregio di stimolare una visione ed una prospettiva sovra-nazionale, a favorire una riflessione autonoma e personale sull’interazione fra le contraddizioni mondiali del sistema economico, somma rappresentazione odierna dei massimi sistemi, e quelle nazionali, regionali e/o locali.
I movimenti avvertono nitidamente che l’eterogenea consistenza sociale da cui sono composti, saldamente nelle mani di questo ceto medio in via di proletarizzazione, tende a livellarsi verso il basso per il convergere di colossali interessi economici i cui principali portatori un tempo erano loro alleati di ferro dei micro-interessi privati locali: la loro azione precorre la sollevazione popolare mondiale che porterà alla definitiva disgregazione di questo modello economico-politico-sociale.
La percezione classista non ha ancora definitivamente preso il sopravvento e al momento cercano di muoversi secondo uno schema di trasversalità politica, assumendo l’idea di una generica «cittadinanza» contrapposta allo schiacciante potere di un coacervo di interessi politico-economici nazionali e transnazionali.
Ma la riflessione accesa su livelli non locali delle interazioni nella società civile, la decollocazione geografica e la sempre più evidente perdita quotidiana del potere di acquisto li stimola ad un confronto sempre più serrato con analoghe realtà extra-territoriali, infondendo loro una coscienza che si allontana dall’«amor patrio» ad una velocità esponenziale, per far loro avvertire una situazione di disagio analoga in qualunque angolo del mondo, più omogenea, affine e contigua alle proprie rivendicazioni di quanto non lo siano i grandi interessi nazionali.
L’approccio internazionalista alle problematiche, istanza suprema del materialismo storico e dialettico si fa strada da solo presso questi presidi di mobilitazione permanente, senza scomodare filosofi e filosofie, in virtù dell’evoluzione naturale del principio del «maggior bene comune» che si rende immanente nel perseguimento del cosiddetto «sviluppo sostenibile» e si radica e acuisce ogni qualvolta sia individuato un ostacolo che l’odierno modo di produzione gli abbia frapposto.
Dunque la condivisione internazionale di tematiche con gruppi, mobilitazioni e/o raggruppamenti analoghi rende vani e irrealizzabili percorsi votati alla «solidarietà interclassista nazionale»: in altre parole non ci sente più italiani perché un groviglio di interessi politico-economici che si identifica con lo Stato stesso - benché non ne rappresenti la maggioranza in termini di consenso - richiama ciascun «cittadino» ad un senso di responsabilità nazionale, invochi uno spirito edificante e di concordia, ricerchi una conferma di un pactum societatis che ormai non ha più senso di esistere se non nell’immaginario di quei pochi che ancora ne traggono qualche beneficio, nell’intento di dare luogo ad un’opera - come la tratta Torino-Lione della TAV o il fantomatico Ponte sullo Stretto - di pubblico interesse e capace di ingenerare progresso.
In realtà la costrizione determina le condizioni per una sensibile perdita di identità e sensibilità nazionale, un allontanamento coattivo dai valori patri che iniziano ad apparire per ciò che realmente sono: principi svuotati dal pragmatismo connaturato all’interesse privato di pochi.
Ed ecco che in tutta la sua naturalezza, spontaneità ed irrefrenabile, incontenibile ed irreversibile potenza si manifesta la superiorità argomentativa di un indirizzo che protende all’avvenire sulle risicate motivazioni di una tendenza retrograda, obsolescente ancorché sdoganata molto spesso come «progresso» identificato per antonomasia con il «progresso tecnologico» che trattazioni superlative come quella dell’antropologo culturale Claude Lévi-Strauss, hanno ampiamente
dimostrato inconsistente, irragionevole, fuori dal seminato.
Franco Battiato nella sua intramontabile «New Frontiers» afferma che «l’evoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta da un’evoluzione di pensiero» e, benché alludesse ad altro, il contenuto di questo versetto sono facilmente applicabili anche all’idea per cui il «progresso tecnologico» ingeneri «evoluzione sociale» in un contesto in cui sia dato per scontato che di esso si debbano accettare incondizionatamente le poche conseguenze positive (ad esempio il recupero di qualche posto di lavoro), trascurando o facendo finta che non ci siano conseguenze negative.
La Val di Susa diviene eminentemente paradigma di una ricerca di «evoluzione sociale» passante per una consapevolezza preventiva non candidamente costernata, compiacente e/o genuflessa di fronte alle lusinghe e ai richiami del «progresso tecnologico» fine a sé stesso, ovvero ai sordidi e ingannevoli tentativi di adescamento disseminati dai grandi interessi politico-economici nazionali.
E «Chiara», a dispetto della dovizia argomentativa che la rende in qualche modo inconsapevolmente vicina alle più nobili manifestazioni della «teoria del maggior bene comune», se no fa propria una certa scaletta di priorità metodologiche, finirà per scegliere sua sponte una collocazione che, ancorché edotta, non la renderà disaffine dalle limbiche dislocazioni dei vari «Ultimo», «Tito», «Luigi» e così via, sfiorando di un soffio il metodo che la potrebbe condurre alla verità, ma che invece la rende soltanto più simpatica, affabile e gradevole di loro nella contrapposizione politica, senza assicurarle per questo la soddisfazione di vedere aldilà dell’impalpabile Velo di Maya.
Alessio Niccolai
 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO18/7/2011 - 10:25
AUTORE:15/7/2011 - 14:09
AUTORE:Quando si scrive ci si rivolge prima di tutto a sé stessi, invocando inconsciamente una pronta rilettura dell'opera esattamente come se fosse stata scritta da qualcun altro.
È un modo per rendere onore all'epigrafe dell'antico Tempio di Delfo tanto cara a Sigmund Freud: «Conosci te stesso».
Ma è anche un modo per stimolare e condividere riflessioni che non siano le arselle a Marina di Vecchiano o il Palio dei Rioni (senza nulla togliere ad entrambi gli argomenti).
Ognuno ha il proprio Velo di Maya che preclude in parte o del tutto la percezione dell'orizzonte, nessuno escluso: la grande consolazione è che lo si può rimuovere ed è come minimo doveroso provare a farlo.
15/7/2011 - 11:37
AUTORE:14/7/2011 - 20:05
AUTORE:All'anima der filosafo! Chiama e rispondi: allòra se Bottiglione è un filosafo Beppe della Sandrina o 'rpovero Palermo 'osa erino?
O bi' se'ondo me siei ma un ber frescone: vando si parla di filosofia 'ontemporanea si ragiona di Aso' Rosa, di Lukacce e vvia disco'rendo.
A 'ddi' ccosì è guasi 'ome se tu volessi sostene' l'intelligenza di Giuliano Fe'rara, l'onestà der Berluska o che Minzolini 'onni tanto dice varcosa di vero.
Er prossimo chi è?!? 'un è mia Arcide De Gaspari per caso? Bisognerebbe ma leva' tutti i tona'oni dar dispensa' l'idea d'esse' filosafi: 'un ce n'è di spazio vi per e preti, vesta vi è disciprina seria che de' attolici e de' gristiani 'ngenerale ne pòr fa' anch'a mmeno.
Ver'ebbe da ditti di'nda' a ffa' 'na girata, ma mi'a una vorta: pensaci bene, ha' citato du' vecchie 'ornacchie der Pentapartito, 'rprimo che 'un ha nemmen provato a vvergognassi d'esse stato demogristiano, e 'rseondo invece 'he dice d'esse contro Berluska e di Centro-Sinistra... ma se'ondo te la gente 'un lo sa che è socialista?
Ma io 'un ce l'ho mi'a 'on nessuno, ce l'ho 'on quer torsolo der Niccolai 'he ti fa anco disco're, te e vell'artri vattro o cinque.
'un ti ci devi 'onfonde 'on questi vi, ma co'a speri di levacci? Vando va bene en socialisti e lo dovresti sape' che di verità 'un ne voglin senti' parla', vando va male ti ci stioccano Bottiglione 'ome filosafo e allòra se ppermatti, anco la Zoppa di Montinero pòr fa er Presidente della Repubbri'a.
En disperati, 'un lo vedi? 'un ni riesce più di sbarca'l'lunario, 'un c'è più posti in pubbri'a amministrazione da spartissi, ci provino 'on le liste civi'e e gni va male e a Vecchiano 'un n'è riescito neanco di circui' er Piddì.
Li trovi a co're a piedi o 'nbiciretta ti salutano par guasi 'he ti voglino 'nvità a ccena e vando ha' girato le spalle en già li pronti a tiratti una 'ortellata.
C'han le Kee ner capo e te gni vai a ragiona' di filosofia? Con que' discorsi lì 'un c'hanno mi'a nulla da guadagnacci: loro vanno ar sodo e se 'un c'è e va'ini vanno 'ndòmo a te e alla 'omunità.
Ne 'onoscin tre o quattro a malapena di filosafi giusto perché hanno ragionato di va'ini, o mmeglio, avrebbano ragionato d'e'onomia, ma sa' 'om'è? Loro enno spiccioli: se 'un s'intende subito dov'è 'rguadagno, allòra ha' detto si'uramente delle bischerate.
Eppoi gni vai a disco're 'nItaliano a bbono, 'he se son di Vecchiano 'ntendano a malapena 'rnodi'ese.
E ssai, 'un demordano, eh! Ha' visto la Lega dopo 'rfigurone all'amministrative 'ome s'è chetata per benino? la 'hiamano dignità, 'he di solito s'accosta bene alla tolleranza, ma 'nquer caso lì 'rPadreterno deve ave' fatto un mira'olo o un gocciolino di 'onfusione... fatto sta che se Diovòle un si sentin più e vando avranno preso la strusciata finale anco 'nPadania si potrà sperà che si siano levati da 'o.....i per sempre! E 'nvece vest'artri vi en come la gremigna: ha' voglia te di Piddue, Pittre e Picquattro, più l'ar'esti e più en lì a elemosina' 'rposticino, a infilassi (sempre dove c'è e va'ini, ma vò vede' òra cor Tremonti er Federalismo Fiscale 'ome la mettano: saran bòni a ri'upera' e tesoretti, o trova' e sordi anco ndove 'un sono?).
Ci manca solo 'he varcuno di lòro lì provi ora a risponditi alla lettera, 'osì siamo si'uri 'he 'ntant'anni d'onorata 'ar'iera gni c'è 'ncastrato anco d'impara' a llegge!
14/7/2011 - 18:17
AUTORE:Ciò che ho ritenuto di dover scrivere rappresenta qualcosa di estremamente mirato nella ricerca del proprio interlocutore: deliberatamente non intende essere compreso da tutti.
Non c'è bisogno di scomodare Bodei o Tabucchi, ne mi interessa che sia opportunamente decodificato o ridotto alla non desueta costruzione del periodo «hemingwayiana» (addizionata però dei canonici errori grammaticali e sintattici non comuni al celebre autore, simbolo del minimalismo e dell'essenzialità linguistici) in voga sul Forum.
Mi fossi rivolto ai vari Tito, Ultimo & C. avrei sicuramente fatto ricorso ad un'altra tipologia di comunicazione: il punto è proprio questo, ovvero che la moltitudine di nickname che affolla il Forum, utilizzate molto spesso «come qualcosa nel posto del niente», non soltanto ha il dovere morale di procedere ad una confutazione puntuale, precisa e argomentata di un intervento come questo, ma per farlo non si può neanche limitare alla rituale operazione di screditamento della persona: occorre esporsi e dire di sé molto di più di quanto non faccia il ricorso perenne e sistematico all'anonimato.
Temo siano proprio taluni pretesi professori di filosofia a non voler comprendere o a non accettare la rielaborazione di molti argomenti intorno ai quali hanno magari dissertato per anni senza ricavarne una propria personale rivisitazione, senza mai trarne il benché minimo spunto personale.
Chiamare in causa Bodei o Tabucchi è atteggiamento tipico di questo genere di Don Rodrigo, perennemente avvolto dalle proprie seghe mentali intorno alle magari centinaia di testi letti e malamente o vagamente assimilati, scarsamente rielaborati e, evidentemente mai utili a elevarlo verso il sapere; dev'essere atroce il dolore prodotto dall'aver letto un'opera e non averne ricavato qualcosa di buono per sé stessi, in una prodigiosa operazione di auto-convincimento dell'esito contrario.
Cadono tutte le proprie miserevoli certezze nel tentativo agonizzante di trovare un conforto nel grande nome, nella disperata ricerca di evitare l'auto-confutazione, l'autocritica, nel tentativo estremo di evitare l'auto-dissoluzione intellettiva e psicologica.
Rifugiarsi nel mondo accademico non assolverà chi filosofeggi speculativamente intorno alla mia dissertazione, ne' chi piagnucoli in cerca di risposte che la lettura non è stata in grado di dargli.
E comunque rivela molto di più dell'identità di un anonimo un intervento di questo genere del veder scritto il nome e cognome del suo autore.
14/7/2011 - 17:37
AUTORE:14/7/2011 - 17:04
AUTORE:Non era più semplice dichiarare un errore di scrittura?
Caro Professore ma lei ce l'ha proprio con tutti!!
Batta, per favore, "dissenzo" su un motore di ricerca qualsiasi e vedrà cosa succede.
Non è un errore di scrittura ma un dubbio che mi è sorto successivamente alla scrittura della risposta.
Guardando in Internet mi è anche venuta l'idea che i due termini fossero equivalenti (ci sono alcune eccezioni anche italiano) ma andando nella pagina di Etimologia il lemma dissenzo non esiste.
Ho ritenuto utile fare la precisazione "ad usum delfini", ed anche per i professori.
Un cordiale saluto
Il Redattore
14/7/2011 - 16:48
AUTORE:Potrei farlo personalmente, ma temo che i tre studiosi interpreterebbero il mio ardire come un'offesa alle loro persone.
Potrei rivolgermi ad altri filosofi del calibro di Rocco Buttiglione, Eugenio Scalfari o Luciano De Crescenzo, che usi ad altro genere di filosofia, gradirebbero alquanto l'essere richiesti di tale esercizio.
Ma preferirei leggere la sintesi che potrebbe farne, bontà sua, il Signor Ganascia, che se ha definito "edotto" il testo di Niccolai significa che lo ha perfettamente capito ed è in grado di spiegarcelo.
e al Ganascia che lo ha definito "edotto"
14/7/2011 - 16:14
AUTORE:L'unico errore del Niccolai è al solito quello di "dare perle in pasto ai maiali" come già dimostra la prima emblematica risposta: la trattazione è eccellente da tutti i punti di vista, ma spesa male per il livello medio di comprensione e per le scarsissime capacità di lettura vecchianesi.
14/7/2011 - 15:05
AUTORE:14/7/2011 - 14:41
AUTORE:Chiunque invia lettere con preghiera di pubblicazione può avere accesso poichè esprime una propria opinione in libertà.
Sta poi al lettore giudicare l'utilità o meno di quanto pubblicato con la possibilità di passare ad altro.
(**)Mi correggo, la parola corretta è dissenso, con la s che deriva dal latino "dissensus". Non esiste in italiano il lemma "dissenzo" nonostante venga usato normalmente da molti giornalisti)
14/7/2011 - 12:17
AUTORE:Mi chiedo se i responsabili di questo giornale abbiano letto questo vaneggiante testo di pseudofilosofia, e se lo hanno letto mi domando per quale fine, che non sia spiritosaggine, o per burlarsi dell'autore, lo abbiano reso pubblico.