
Un paese che amo, il paese della mia mamma.Anche ora quando vado a RIPAFRATTA sono la figlia della "Cocca".
Un paese con una storia importante che conserva vestigia di grande rilievo.
Un paese rimasto inalterato nel tempo, non ci sono insediamenti nuovi, potrebbe essere il set di film d'epoca perché anche le case, le facciate conservano la patina del tempo.Un paese che è ancora comunità.



Il primo fu il .....










-
Abbattimento dei 35 tigli sulla Provinciale Ripafratta-Cerasomma [1]
-
Landini È ossessionato dal job act e da Renzi [2]
-
Da molto tempo dovevano essere fermati, spero ci sia un inferno abbastanza adeguato alla loro malvagità [3]
-
Siamo cresciute insieme: 4 alberi in ricordo di Francesca, Paola, Valeria e Virginia [2]
-
Il Molino Grassotti di Paola Gavia [1]
-
CHE PIACCIA O NON PIACCIA MATTEO RENZI E’ UNO STATISTA [3]
-
Le 17 regole della propaganda russa. [1]

di Valdo Mori



di Valdo Mori





San Giuliano Terme, 24 aprile




viene considerato un inevitabile passaggio
alla fine del faticoso viaggio
vissuto da tutti con coraggio?
Il .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
AGRIFIERA 2025: PRESENTATA LA 115ª EDIZIONE [271]
-
Laghetti di Campo: una nuova istanza per un grande impianto fotovoltaico di una ditta privata [168]
-
I giochi di cortile. [145]
-
PAPPIANA VINCE VS "ANGELO BELLANI".E' SALDAMENTE AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. RETI DI PAVOLETTONI E STABILE [140]
-
Siamo cresciute insieme: 4 alberi in ricordo di Francesca, Paola, Valeria e Virginia [136]
-
PONTASSERCHIO VINCE IL DERBY VS MIGLIARINO.SKHURTI CAPOCANNONIERE CON 25 RETI. I VECCHIANESI AI PLAY OFF [122]
-
Al via le operazioni di pulizia della spiaggia a Marina di Vecchiano [121]
-
La nuova eroina antikasta si chiama Rita De Crescenzo, cantante, tiktoker e influencer napoletana. [118]
-
CHE PIACCIA O NON PIACCIA MATTEO RENZI E’ UNO STATISTA [115]
-
Guarda la Natura che ti guarda! [115]
-
Aldo del Gratta ed il suo nuovo romanzo "Averno" [114]
-
Abbattimento dei 35 tigli sulla Provinciale Ripafratta-Cerasomma [102]
-
Le 17 regole della propaganda russa. [99]
-
Da molto tempo dovevano essere fermati, spero ci sia un inferno abbastanza adeguato alla loro malvagità [93]
-
POSTEPAY PRESENTA AL NETCOMM FORUM IL PROPRIO ECOSISTEMA PER UNA “GREAT SHOPPING EXPERIENCE” [86]
Sono partito in quarta nello scrivere di cose del passato senza pensare che sulla Voce vi è anche una partecipazione giovanile che “potrebbe” non essere a conoscenza di particolari termini.
Anche se nessuno dei ragazzi di oggi ha mai visto un navicello e dei renaioli al lavoro, conosce senza dubbio quello che il primo portava e i secondi facevano.
Un caso a parte è la parola e il mondo degli “alzaioli” e dell’alzaio.
Abbiamo visto che il risalire la corrente dl fiume era un pesante lavoro di stanga e remi, quando non c’era vento, e così si era creato un lavoro per i più disgraziati: quel massacrante sussidio umano che sopperiva al motore di là da venire.
Uomini come bestie si legavano grosse funi attorno alla vita e alle spalle e rimorchiavano i pesanti barconi su apposite strisce di terra tenute libere da ostacoli e il governo di allora introdusse una servitù di passaggio, che esiste tuttora, e che prese il nome di “servitù di via alzaia”, una zona libera lungo i corsi d’acqua.
Telemaco Signorini nel 1864 dipinse un meraviglioso quadro che raffigura quel lavoro sull’Arno, “L’alzaia”. (foto 1)
Il nostro viaggio è nello spazio di un fiume, fra la sua ultima gloriosa città di mare e l’altra ancor più grande all’interno, ma non forzatamente nel tempo, allora divaghiamo un poco!
Siamo nel 1753, una attrice, finta nobildonna, Ortensia, dice:
“Per oggi non posso arrivare a Firenze. Da Pisa a qui in navicello ci vogliono almeno tre giorni!”
Risponde l’amica e complice Dejanira:
“Guardate che bestialità! Venire in navicello!”
Le due dame sono personaggi della “Locandiera” goldoniana e non furono certamente, anche se viaggiatori immaginari, i soli a lamentarsi per la lunghezza della durata della navigazione.
Passiamo al 1842 e ad un altro poeta minore, Filippo Pananti, che raccontò in versi un vero viaggio da Firenze a Pisa scelto da un vero gruppo di attori teatrali che volevano spender poco e non avevano fretta.
Se questo viaggio monte-mare era logicamente più veloce, aveva però anch’esso i suoi fastidi: i “calloni”.
I calloni (foto 2) erano e sono delle piccole rapide che, in diversi fiumi a corso veloce, vengono create per rompere la corrente troppo impetuosa facendola ripartire lentamente dopo la cascatella. Sono anche chiamate “pescaie”.
In questi punti i viaggiatori venivano fatti scendere a riva e poi ripresi dopo l’ostacolo, ma sentite cosa successe agli amici di quel viaggio:
[…] dolcemente andavam, quando sentissi
un gran urto e ci parve a quel rumor
precipitar nel fondo degli abissi.
Gridan gli attori - si affoga, si muor,
sono all’inferno, povero infelice,
sono morta, sono una peccatrice-.
Senza fare posare il piede al suolo
così com’è costume in simile occasione,
quel tocco di briccon del barcaiolo
fece il salto nell’acqua del callone
che deve all’uom che non vi si prepara
la cascata parere del Niagara […]
va da sé che gli attori scesero, non pagarono, litigarono e presero una carrozza per Pisa, ma ritorniamo al nostro viaggio.
Siamo arrivati al dantesco paese di Capraia (foto 3), noto per il popolare detto dell’amore con il suo dirimpettaio, ma più noto per il paese che a lui si unisce per formare il comune: Limite.
Si racconta che: “strani uomini arrivarono in questo luogo intorno al 1600, avevano asce che picchiavano da mattina a sera sui legni degli alberi. Furono chiamati “picchiotti” , quelli che fecero nel paese di Limite sull’Arno una loro particolare storia di battelli, bastimenti, navicelli (foto 4 e 5) e in seguito anche mas e addirittura un motoscafo, l’Arno”, che vinse ogni tipo di corse per quei tempi. (foto 6 e 7)
Nel 1837 vararono addirittura 11 vascelli di oltre 30 metri.
Questa loro passione e capacità di costruire grossi bastimenti li ha portati paradossalmente alla loro fine.
Il trasporto che l’Arno offriva si adattava a piccole barche, ma le grosse dovevano essere smontate e trasportate al mare con una colonna di camion ingombranti per le strade comunali e provinciali con un disagio incredibile per la circolazione.
Il cantiere Picchiotti si trasferì in darsena a Viareggio e poi fu venduto alla società Perini.
Interessante era però il varo e la discesa dei velieri al mare via acqua.
Da Limite a Marina di Pisa vi sono 16 ponti che andavano sottopassati.
Se c’era tanta acqua era impossibile, battevano la “testa”, se invece l’acqua era poca battevano il “culo” e quindi bisognava aspettare il livello ottimale che veniva segnalato da osservatori e da segnali idrometrici.
Al momento giusto si doveva partire, a qualunque costo o condizione meteorologica.
La corrente favorevole non lo era al passaggio sotto i ponti perché tutti sanno che una barca per governare deve andare più forte della corrente, altrimenti il timone lavorerebbe a vuoto, quindi per far aumentare la velocità del bastimento questo si faceva trainare da alcuni navicelli a 12 o 16 remi che lo portavano a superare lo scorrere dell’Arno e quindi far timonare per non urtare nei piloni.
Quegli uomini che rendevano possibile queste manovre erano pescatori e renaioli e inventarono, senza volerlo, la meravigliosa arte del canottaggio.
I canottieri di Limite sull’Arno, nome a loro dedicato dal solo indumento che li rivestiva e ne lasciava liberi i movimenti, la canotta che indossavano, si cimentarono con i prestigiosi universitari inglesi di Oxford e con i forti balenieri portoghesi e stracciarono quegli equipaggi invincibili.
Cosa stanno pescando quei barchetti vicino al ponte?
Sono “eppie” quei pesci che rimarranno presi, le cheppie che risalivano i nostri fiumi e deponevano le uova nelle pietraie, pesci che hanno lasciato il posto ai nuovi invasori che si adattano ad ogni qualità di acqua! (foto 8), come pure sono scomparse quelle dolci figure di lavandaie che facevano il loro bucato sbattendolo sui sassi e strusciandolo con sapone di Marsiglia su scranni di legno. (foto9)
Ancora più avanti si incontrano gli ultimi renaioli che setacciane le piagge ancora vergini (foto 10) e finalmente si intravede la città del giglio.
Sulle rive una incantevole folla di madamine con l’ombrellino, signori in cilindro e bastone e carrozze per i pigri affollano le Cascine, il grande parco di Firenze (foto11), ma l’Arno?
I fiorentini, dopo anni di passeggiate sulle rive, il 15 settembre 1932, vararono la motonave “Fiorenza”, logicamente cantiere Picchiotti! (foto 12). Fu ancorata vicino al ponte di Santa Trinita e trasportava viaggiatori fino alla Pescaia di Santa Rosa per gite al tramonto (tre lire) o concerto e danze serali (cinque lire).
Il breve percorso stancò velocemente i fiorentini e i proprietari decisero di vendere la motonave a una società del nord.
La Fiorenza fu allungata di 8 metri e partì in camion per il Po dove, appena scesa in acqua, una improvvisa piena la trascinò in mare e i fiorentini, che poco la usarono, non ne seppero più niente e i polesani, che l’avrebbero usata, non la provarono nemmeno!
Finita la Fiorenza, finito il nostro viaggio e finita la mia fatica!






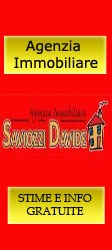
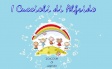
















 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO