
Un paese che amo, il paese della mia mamma.Anche ora quando vado a RIPAFRATTA sono la figlia della "Cocca".
Un paese con una storia importante che conserva vestigia di grande rilievo.
Un paese rimasto inalterato nel tempo, non ci sono insediamenti nuovi, potrebbe essere il set di film d'epoca perché anche le case, le facciate conservano la patina del tempo.Un paese che è ancora comunità.



Il primo fu il .....










-
Abbattimento dei 35 tigli sulla Provinciale Ripafratta-Cerasomma [1]
-
Landini È ossessionato dal job act e da Renzi [2]
-
Da molto tempo dovevano essere fermati, spero ci sia un inferno abbastanza adeguato alla loro malvagità [3]
-
Siamo cresciute insieme: 4 alberi in ricordo di Francesca, Paola, Valeria e Virginia [2]
-
Il Molino Grassotti di Paola Gavia [1]
-
CHE PIACCIA O NON PIACCIA MATTEO RENZI E’ UNO STATISTA [3]
-
Le 17 regole della propaganda russa. [1]

di Valdo Mori



di Valdo Mori





San Giuliano Terme, 24 aprile




viene considerato un inevitabile passaggio
alla fine del faticoso viaggio
vissuto da tutti con coraggio?
Il .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
AGRIFIERA 2025: PRESENTATA LA 115ª EDIZIONE [271]
-
Laghetti di Campo: una nuova istanza per un grande impianto fotovoltaico di una ditta privata [168]
-
I giochi di cortile. [145]
-
PAPPIANA VINCE VS "ANGELO BELLANI".E' SALDAMENTE AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. RETI DI PAVOLETTONI E STABILE [140]
-
Siamo cresciute insieme: 4 alberi in ricordo di Francesca, Paola, Valeria e Virginia [136]
-
PONTASSERCHIO VINCE IL DERBY VS MIGLIARINO.SKHURTI CAPOCANNONIERE CON 25 RETI. I VECCHIANESI AI PLAY OFF [122]
-
Al via le operazioni di pulizia della spiaggia a Marina di Vecchiano [121]
-
La nuova eroina antikasta si chiama Rita De Crescenzo, cantante, tiktoker e influencer napoletana. [118]
-
CHE PIACCIA O NON PIACCIA MATTEO RENZI E’ UNO STATISTA [115]
-
Guarda la Natura che ti guarda! [115]
-
Aldo del Gratta ed il suo nuovo romanzo "Averno" [114]
-
Abbattimento dei 35 tigli sulla Provinciale Ripafratta-Cerasomma [102]
-
Le 17 regole della propaganda russa. [99]
-
Da molto tempo dovevano essere fermati, spero ci sia un inferno abbastanza adeguato alla loro malvagità [93]
-
POSTEPAY PRESENTA AL NETCOMM FORUM IL PROPRIO ECOSISTEMA PER UNA “GREAT SHOPPING EXPERIENCE” [86]
Restiamo ancora in tema di ricette, ma questa volta rigorosamente pisane.
Facciamo passare diversi secoli di "mangiar toscano" e fermiamoci a mezzo fa.
Le quattro ricette qui riportate sono tratte da "L’Almanacco pisano 1962", curato da Emilio Tolaini per la casa editrice Nistri-Lischi.
Nel 1962, son passati cinquantanni esatti, alcuni scrittori pisani proposero la loro rivisitazione di notissimi piatti della tradizione locale e non potevano che cominciare, per la penna sublime di Enzo Carli, dalle:
cèe alla sarvia
Nel centenario dell’Unità Nazionale, siano resi i debiti onori anche a questo piatto che, fra i tanti “ritrovati d’invenzione” di cui mena giusto vanto la più che millenaria civiltà pisana, è senza dubbio quello che più si presta ad essere apprezzato dall’universale. in quanto a ben intenderne le secrete virtù non necessita dottrina veruna, e neppure stomaco forte essendo esso cosa delicatissima e di facilissima digeribilità.
E innanzi tutto, cèe, cieche o ceche, e perché si chiaman così? La cèa infatti non è per niente cieca, o per lo lo meno niente ci autorizza a ritenere che non ci veda con quegli occhini microscopici, con quei puntolini nerissimi che bucano la vetrina trasparenza del suo corpicciolo.
Misteriosa dunque, e forse remotissima, è l’origine del suo nome, che corrisponde alla « civelle, » dei frarcesi, come pieno di misteri è ancora il romanzo della sua vita, uno dei più affascinanti tra quanti madre Natura proponga agli scienziati e ai poeti. Poiché la cèa altro non è che l’anguilla “pur mo’ " nata, l’anguilla appena uscita dallo stato larvale di leptocefalo, e decisasi a diventare anguilla: e così piccina e fragile e indifesa, ha già percorso cinquemila chilometri di oceano, dal mar dei Sargassi dove nacque e nei cui abissi avrà la tomba alle sponde d’Arno dove il Pisano nelle fredde notti d’inverno pazientemente la cattura: e per quelle il romanzo è finito.
Ma nessuno sa come nascano le cee, e nessuno ha mai visto un’anguilla morta di vecchiaia. Quando la cèa si presenta a Bocca d’Arno e comincia a rimontare il corso ha circa tre anni d’età, e si è già trasformata in pesce di acqua dolce: fattasi più sottile e assunta una forma cilindrica, si accinge ad un cimento supremo, dal quale non la distoglieranno né violenze di opposte correnti né vortici o rapide o mulinelli, né tumulto di cascate né salti rocciosi o secche motose.
Teme solo la luce, la piccola intrepida, e per questo, mentre di giorno s’infossa nel limo e riposa, viaggia di notte, e più la notte è scura, fredda e tempestosa, più si sente protetta dalle insidie che la minacciano. Non però, ahimè! dalla ripaiola del pescatore pisano, perché questa nuova insidia non era scritta all’origine nel libro del suo destino: e il Pisano, che lo sa, quando comincia la stagione, la quale va da dopo Natale ai primi di marzo (più tardi no, chè si comincia a sentir troppo la lisca e il loto), sull’imbrunire calza stivali, si munisce di ripaiola e lanternino e scende al fiume.
Il barchetto a fondo piatto è utile, ma non indispensabile, chè la pesca si può fare anche dalla proda: la ripaiola da cèe, com’è fatta, ve la descrive in questo stesso libro, con la sua profonda competenza, Maria Malagrazia, e il lanternino serve per vedere le cèe rimaste nella ripaiola e travasarle nel bussolo.
E’ una pesca lenta, faticosa, e scomoda, sempre con le braccia protese a scucchiar nell’acque buie, le mani che s’intirizziscono e gelano, e ogni volta non più di due, tre o quattro cèe, e qualche volta anche niente.
Sul ponte di ferro passano rintronando i direttissimi tutti illuminati, soffici, ben riscaldati, vanno a Viareggio, a Genova, a Parigi: sotto, nella gran vallata umida e nera vagano in silenzio come anime sperdute i fiochi lanternini dei pescatori di cèe.
La mattina le cèe sono sui carretti, al mercato: quando non sono pescate di frodo, in periodi in cui la pesca è proibita (nel qual caso starò zitto tutto sta nell’avere amici e quattrini) le metton nelle corbe, rivestite però internamente da un telo ben fitto, per impedire fughe dagli interstizi: sono una massa aggrovigliolata, vischiosa, di colore grigiastro, apparentemente immobile, ma viceversa, a guardarla da vicino, tutta formicolante, piena di sussulti, di scivolamenti, di fremiti, e quando il pesciaiolo ci affonda le mani, per pescarvi quelle che vi porterete a casa, chiude subito l’involto pesante e molliccio di carta gialla.
Per quanto, fino a che non sentono il caldo, è difficile che le cee scappino, o per lo meno non vanno molto lontano.
Ed ecco come si cucinano.
Mettete un tegame di ferro smaltato o d’alluminio, che fa lo stesso, ben profondo, al fuoco, con molto olio di quello buonissimo, genuino dei nostri oliveti al piè di monte (e non fatto con gli esteri e coi somari morti) e insieme un ramoscello di salvia, Poi stendete sul tavolo un canovaccio di balIa, grosso e ruvidissimo, ci spargete sopra le cèe e con un lembo, o una còcca, del canovaccio, le soffregate energicamente, in modo da liberarle dalla patina vischiosa che le ricopre: un’operazione crudele, ma indispensabile. Quindi raccogliete con cura le cée dentro un colino fitto, da brodo, e le lavate sotto il rubinetto, ad acqua corrente: lì seguiteranno a liberarsi della schiumetta che le impastoia, e che sembra un po’ una saponata.
Nel frattempo l’olio al fuoco si sarà scaldato, e darà indizio di spiccare il bollore: ve ne accorgerete dalle foglie della salvia che cominciano ad accartocciarsi.
E’ questo il momento decisivo ma attenzione!
Le povere bestiole, dopo quel po’ po’ di servizio che gli avete fatto, sembreranno morte, o moribonde, o se ne staranno li ringrullite: invece sono ancora tutte vivissirne. Quindi, quando si butta il malloppo nel tegame, bisogna star pronti col coperchio in mano e coprirlo immediatamente, perché appena sentito il vapore caldo, le cèe rinviviscono di colpo e con incredibile energia schizzano fuori e si spargono per tutta la cucina, seguitando a divincolarsi come minuscoli serpentelli.
Tenete qualche minuto, due o tre, il tegame coperto, e quindi aprite per aggiungere un po’ di sale: è tutto, non occorre altro, e basterà lasciar cuocere lentamente, ma evitando che l’olio si ritiri troppo perché questo, mescolandosi a quel resto di viscosità che le piccinine seguiteranno a spremere, formerà quel sughino che sarà il più delizioso condimento alle loro tenerissime carni. Non aggiungete, come fanno taluni, della conserva di pomodoro, gravissimo errore perché questa, col suo forte e villano sapore, anche se in quantità limitatissima, finirà per prendere il sopravvento. Tutt’al più, quando le avete sul piatto, cospargetele con un pizzico di parmigiano grattugiato: ma anche questo non è necessario, è roba da trippa, e le cèe sono infinitamente più delicate, e bisogna lasciare inalterato il loro sottilissimo aroma, in cui il profumo della domestica salvia misteriosamente si congiunge al ricordo di placide foci fluviali, di canne ondeggianti sulle acque. di aperte lontananze marine.
Quando sono cotte, la loro carne è bianchissima e fa ancor più spiccare il nero degli occhietti: onde ci son degli schizzinosi (non tra i pisani però, sicché sarà meglio chiamarli alla senese «spizzèi». o « spizzecoli ») cui fanno effetto, dicon che sembran bachi e si rifiutano financo di assaggiarle.
Sciagurati e infelici!
Chè essi non possono immaginare come quei fili intrecciati e ammatassati siano ben lontani dalla schifosa mollezza del verme, non faccian mai poltiglia, ma mantengano, pur nella estrema morbidezza, una certa qual consistenza di carne, dovuta alla loro esilissima, embrionale lisca: la quale tuttavia in quelle tardive, o marzaiole, comincia a farsi sentire troppo, e allora sono assai meno buone.
Per un piatto così semplice, così casalingo, sarebbe di prammatica consigliare di berci sopra del vino bianco delle nostre colline pisane, di verso Lari o Peccioli: e sia, ché ve n’è di ottimi, ma non assolutamente eccezionali.
Ma se avete in cantina una bottiglia di bianco secco di Bordeaux, della Mosella, o di Riesling d’Alsazia è meglio: beveteci quella. ché le cèe ne son degnissime, e a tavola non si fanno nazionalismi.
Enzo Carli
La lunghezza dell'articolo mi sconsiglia di proporre anche le altre tre ricette pisane e quindi...alla prossima, e non vi fate venire l'acquolina in bocca ché le cee non si trovano più se non rischiando multe salatissime quasi quanto salatone sarebbe il loro acquisto al mercato nero (bianco in questo caso!)



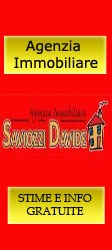
















 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO