
Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.
Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.













-
Risposta fotografica e scritta [3]
-
25 aprile 2025 [4]
-
BOBINA DI TESLA IN AGRIFIERA 2.000.000 di Volt [1]
-
Ma che banda! [3]
-
L'Annunziata (Lucia) ha detto una frase che credo superi qualsiasi caxxata lei abbia mai pronunciato [2]
-
Oggi e i colori. [2]
-
ANCHE A PASQUA SI APRONO GLI STADI. SI GIOCA ANCHE LA SERA DEL SABATO SANTO E LEGGETE LA CITTA' CHE GIOCA [4]


di Valdo Mori











Ma è inevitabile
Chiudo gli occhi per non guardare
Ma quella livida rigidità
appare scompare riappare
Io ti .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
In seconda categoria Il Migliarino/Vecchiano ai play off. Domenica 27 ore 16,00 in casa vs San Vitale Candia [169]
-
L'Annunziata (Lucia) ha detto una frase che credo superi qualsiasi caxxata lei abbia mai pronunciato [162]
-
Agrifiera 2025 è qui! Vi aspettiamo dal 23 aprile al 4 maggio [156]
-
Transizione ecologica non vuol dire devastazione del territorio. [155]
-
Ma che banda! [150]
-
Oggi e i colori. [132]
-
Petalo bianco-L’illusione degli anti Meloni di acchiappare voti con un partitino cattolico [132]
-
Liberazione: le celebrazioni a San Giuliano Terme [121]
-
Insediamento nuovo parroco parrocchia San Frediano in vecchiano [119]
-
Massimo Cacciari attacca Elly Schlein: " Il 25 Aprile? La sinistra di ogginon ha nulla a che vedere con la Resistenza" [119]
-
"AVERNO" LIBRO DI ALDO DEL GRATTA 28 APRILE ORE 17,00 AGRIFIERA PONTASSERCHIO [109]
-
1° Maggio festa del lavoro – Spazio Donna per il lavoro invisibile [107]
-
#80esimodellaLiberazione #25Aprile [95]
-
Lasciate perdere tutti coloro che hanno fatto la lista di chi non doveva esserci. [93]
-
Celebrata la Liberazione al monumento dell'eccidio della Romagna [88]
di Mario Vattani
Historiae (di M.Vattani). Hiroshima: sotto la cenere il profumo di onore e coraggio
Sotto la cenere, onore e coraggio sono i valori che fanno la differenza
Il piatto tipico di Hiroshima è l’okonomiyaki. Significa più o meno: “cuocila come ti pare”, ed è una specie di frittata a base di pastella, spaghetti, cavolo tagliato a strisce finissime, e pochi altri ingredienti.
E’ un piatto povero, che si cucina su una grande piastra, quasi un tavolo di acciaio attorno al quale si accomodano gli avventori. Chi si siede riceve due strumenti: una specie di cucchiaio – fatto come una piccola paletta – e un grande boccale di birra che si appanna subito per la condensa.
Funziona così: il cuoco, che è in piedi dall’altra parte della piastra, prepara prima la base del tortino, poi sposta l’okonomiyaki di fronte ad ogni cliente, che lo cucina da sé. Non ci sono piatti, si mangia direttamente dalla piastra, usando la paletta di metallo.
Si capisce che l’atmosfera in questi piccoli locali è allegra, semplice, e fumosa. Anche se si è soli, in un attimo ecco che ci si trova a chiacchierare con la cuoca, poi con il vicino, e si finisce per passare una bella serata nel quartiere di Nagarekawa. E’ li che si trovano le più vecchie trattorie di questo genere, che hanno tutte un nome di donna.
Ogni volta che si apre la porta scorrevole da “Machiko”, “Tomoko”, “Asuka”, “Rie”, esce nella strada l’odore della pastella che frigge sulla piastra, il fumo delle sigarette, il vapore che insieme alle voci e alle risate si arrampica su per le insegne illuminate di tutti quei bar, di tutti quei locali, su per i tetti silenziosi fino al cielo di Hiroshima, senza una nuvola.
* * *
Ad agosto, anche di prima mattina, il cielo di Hiroshima è quasi bianco, per quanto fa caldo. Quindi quel giorno, verso le 7.30 il primo aereo fu avvistato con largo anticipo, anche se volava ad altissima quota, e subito scattarono le sirene. Tutti corsero ai rifugi, ma dopo mezz’ora ancora non era successo nulla. Il B29 era scomparso da un pezzo, allora l’antiaerea suonò il cessato allarme, e si tornò di nuovo nelle strade.
Ai ragazzi delle scuole adesso rimaneva poco tempo per finire i turni obbligatori di demolizione, quelli per la prevenzione anti-incendio, prima di correre a lezione.
Ma proprio in quel momento, alle 8.15, troppo tardi per dare di nuovo l’allarme, si materializzò il secondo B29. Sull’ala verticale aveva una grande R cerchiata, e sulla fusoliera portava il nome Enola Gay. L’apparecchio che lo aveva preceduto era ormai a diverse miglia di distanza, ma si preparava comunque a ripassare: la sua missione infatti era di scattare una serie di fotografie della città.
Prima, e dopo che un occhio di luce accecante si spalancasse nel cielo cinquecento metri sopra il centro di Hiroshima, cancellasse in un secondo la vita di quasi ottantamila persone, facesse bruciare l’aria, bollire l’acqua del fiume, polverizzare il cemento, piegare l’acciaio, fondere il vetro e il granito, per poi richiudersi nascondendo il mondo in una nebbia incandescente di cenere e fumo. Subito dopo, una pioggia nera che nulla ha mai lavato, promise l’inferno ad altri quarantamila abitanti di Hiroshima, morti nei giorni e nelle settimane successivi, tra sofferenze inenarrabili. Per tutti coloro che furono esposti a quella luce, anche negli anni a venire restò il marchio della paura, l’attesa che un male incomprensibile si potesse manifestare nel proprio grembo, nel volto, nelle ossa dei propri figli.
* * *
“E’ andata benissimo. Sembra che abbia fatto un gran botto. A tremendous bang”.
Questo il commento a caldo del Generale Groves, direttore del Manhattan Project, in una telefonata al professor Oppenheimer, per complimentarsi del successo.
E pensare che invece da un punto di vista tecnico il “Little Boy” fece praticamente cilecca, per i membri del “Scientific Committee” – Compton, Lawrence, lo stesso Oppenheimer ed Enrico Fermi – i quali avevano insistito, mettendo in minoranza il professor Szilard che si era fatto qualche scrupolo, per sganciare la bomba su un obiettivo civile, “una applicazione militare molto più adatta ad indurre alla resa”.
Nell’esplosione infatti, raggiunse la fusione meno del 2% dell’uranio fissile di cui era caricato l’ordigno.
Come lo sapevano? Perché tutti i dati dell’esperimento furono registrati dalla strumentazione imbarcata sul terzo ed ultimo aereo che volò quel giorno nel cielo di Hiroshima.
Anche lui aveva un nome: The Great Artiste.
Il grande artista. Immaginiamo le esclamazioni, le grida e gli applausi quella mattina, quando si è alzato in cielo l’altissimo mostro di fumo e di fiamme.
Il grande artista lavora all’effetto visivo delle sue opere. Le crea, le presenta e poi dà loro un nome. Così il “fungo atomico” sembra un fenomeno meteorologico, non dissimile da una grande nuvola. Come quelle che guardiamo, sdraiati su un prato a pancia in su, facendole somigliare a piante o animali.
Si chieda a chiunque di raffigurare un’esplosione atomica, e comparirà un fungo.
Il grande artista deve fare i conti con un difficile equilibrio. Occorre raffigurare una situazione reale, su cui si ha scarso controllo, contenendola però in un quadro limitato, le cui misure sono definite. Per questo si noterà che più è grande l’esplosione, più bisogna allontanarsi per allargare il riquadro, più il centro della fotografia si allontana dalla terra, e sale verso il cielo. Quindi paradossalmente, più potente è l’esplosione, più edifici si riescono a distruggere, più persone si riescono ad eliminare, meno sono visibili la distruzione, il dolore e la morte. Alla fine la terra, con i suoi palazzi, le strade, le case, diventa una piccola striscia indefinita, in basso.
Mi è capitato di vedere, via internet, alcune foto di grandi esplosioni causate in questi giorni da bombardamenti aerei. Rappresentavano una vasta nube grigia e nera, con al centro il rossore delle fiamme. Sotto, molto più piccoli, i palazzi, le case, le finestre degli appartamenti. Il primo commento pubblicato da un utente sotto l’immagine era: “wow!”.
Proprio allora è uscita la notizia della morte dell’ultimo membro dell’equipaggio dell’Enola Gay. Non so come si chiamasse, e francamente non mi interessa. Anzi, a dir la verità non sapevo nemmeno che uno di loro fosse ancora vivo. Così sulle stesse pagine ho trovato delle notizie su Hiroshima, insieme a quelle riferite a conflitti contemporanei.
Allora mi sono chiesto se l’adrenalina che corre nelle vene di chi usando missili, bombe oppure lanciando razzi riesce a far alzare il fumo e le fiamme su una città appartenga all’idea di combattimento – quindi alla guerra – oppure a qualcosa di diverso, che si chiama terrore.
Sembra banale scriverlo in questo modo, ma questi avversari pretendono di combattersi a vicenda lanciando potentissimi esplosivi in aree cittadine, abitate da famiglie. E’ naturale che vengano colpiti di volta in volta case, negozi, rifugi, scuole, ospedali. Sarebbe sorprendente il contrario.
Il punto, pur nella sua ovvietà, non è privo di significato, perché normalmente al combattimento si associano non soltanto l’idea di vittoria e di sconfitta, ma anche i valori dell’onore e del coraggio.
Eppure questi valori di onore e di coraggio non si vedono in queste terrificanti fotografie di esplosioni e bombardamenti. Forse perché sono valori che invece appartengono a quanto si svolge in quel sottile spazio più in basso, sotto quelle nuvole di cenere e di fiamme che riempiono il cielo.
Il 6 agosto, in un attimo Hiroshima aveva perso quasi un terzo della sua popolazione, e oltre la metà degli edifici erano stati rasi al suolo dalla bomba.
Ma sotto il grande fungo delle fotografie, la reazione a terra fu immediata. Dopo poche ore, senza sosta, si diresse dalle campagne circostanti verso la città distrutta un flusso di migliaia di persone, per organizzare i soccorsi e prestare le cure necessarie a quella triste massa di feriti e ustionati.
Già dal pomeriggio dello stesso giorno, la marina imperiale iniziava via camion il trasporto dei feriti nelle regioni limitrofe di Saeki, Asa e Aki. Nella notte venne trasformato in crematorio l’intero liceo di Danbara, per evitare che la presenza di così tanti cadaveri potesse causare epidemie. Poi dal 7 agosto, i villaggi tutto intorno alla città iniziarono a spedire ogni giorno a Hiroshima quantità sufficienti di onigiri – le tipiche palle di riso giapponesi – per sfamare i sopravvissuti al bombardamento. Dalle isole arrivavano vestiti, lenzuola, gli scarsi medicinali. Il caldo dei mesi estivi non aiutava, e molti morivano a causa delle infezioni e della cancrena. Difficile immaginare le condizioni impossibili in cui lavorava chi si adoperava per i soccorsi alle vittime, per spostare le macerie e far circolare i mezzi, per ripulire i canali e i corsi d’acqua, ma basti pensare che a poche settimane dal disastro, gli studenti di Hiroshima avevano ripreso i corsi, naturalmente all’aperto.
Ogni giorno, un esercito di sopravvissuti vestiti di stracci, i fantasmi di donne, ragazzi, bambini, vagavano per chilometri nelle macerie alla ricerca dei loro familiari. Come centri di accoglienza vennero utilizzate le scuole, al cui esterno venivano posti dei grandi cartelli con un elenco dei nomi di chi vi si era sistemato.
Per molte mogli, madri, figlie dei soldati che erano andati a combattere nelle isole del Pacifico, la maggiore preoccupazione era come avrebbero fatto quei soldati a ritrovarle, quand’anche fossero ritornati dalla guerra.
Nella grande bidonville che era diventata Hiroshima, per le donne che non potevano allontanarsi perché accudivano a un bimbo piccolo, oppure a un anziano malato, una soluzione era quella di trasformare l’ingresso del loro rifugio temporaneo, e cucinare l’okonomiyaki. Bastava sistemare su mezzo bidone una lastra di metallo, accendervi sotto il fuoco, mescolare con la pastella quei pochi ingredienti che si riuscivano a trovare, e aspettare i clienti.
Sull’entrata si appendeva un cartello con il proprio nome, “Machiko”, “Tomoko”, “Asuka”, “Rie” e si raccomandava agli avventori di spargere la voce, di raccontare in giro che loro erano lì, che erano vive, che il bambino stava bene.
Non c’era bisogno di piatti o di posate, né di sedie, perché ci si sedeva a terra, su una stuoia. Bastavano una piccola paletta, e un vicino disposto a dividere un po’ della sua acquavite. E se per caso gli occhi si fissavano troppo sull’acciaio grigio della piastra, e risaliva d’un tratto gelido come un conato tutto l’orrore, allora ci si faceva canzonare gentilmente dalla padrona di casa, nel suo kimono consunto, con gli occhi stanchi e le maniche legate con il laccio tradizionale, in modo da liberare le braccia. Tanto il piccolo dormiva sul tatami, pochi passi più in là.
Quante volte, nel fumo della pastella che frigge sulla piastra, quella donna avrà sobbalzato sentendo scorrere la porta dell’ingresso. E ogni volta che si affacciava un berretto militare sporco e spiegazzato, avrà sperato di riconoscere il volto che pensava di non rivedere mai più. Forse è anche questo il profumo dell’onore e del coraggio, che si arrampica su per i tetti silenziosi, fino al cielo di Hiroshima.
@barbadilloit




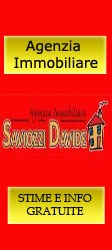








 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO