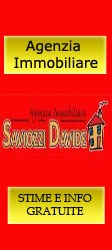Il 15 novembre p.v. L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme apre la stagione del Teatro Rossini di Pontasserchio, con la direzione artistica di Martina Favilla - Presidente dell’Associazione Antitesi Teatro Circo. Una proposta artistica originale e di grande rilevanza, sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme, Regione Toscana, Ministero della Cultura, che posiziona la città di San Giuliano Terme come area della cultura e della multidisciplinarietà con particolare attenzione all’inclusione sociale e alle nuove generazioni, con metodologie innovative.



Secondo me hai letto l'intervista .....










-
Particella negativa! [1]
-
Buongiorno e buona giornata a tutti Matteo Renzi, cosa insegna la collaborazione bipartisan su Raffaele Fitto? [2]
-
Il libanese Salam... [2]
-
Alla scoperta degli eventi sul nostro territorio per il 25 novembre [2]
-
25 novembre 2024 [1]
-
Lo sbarco delle velelle. [1]
-
Lunedì 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. [1]


di Valdo Mori











non parimenti dipinto
Sparsi qua e là
come ciuffi di velo
strani bioccoli di bambagia
che un delicato pennello
intinto .....



-
Il Pontasserchio passa il turno di Coppa Toscana battendo il Gallicano ai rigori dopo il 3 a 3 dei 90 minuti [173]
-
Lunedì 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. [164]
-
"PRINCIPESSE CAPOVOLTE" al Teatro Rossini [154]
-
Lo sbarco delle velelle. [137]
-
Può servire avere autostima ad una donna? [132]
-
Il libro sulla marinese al Fortino [132]
-
Vecchiano Civica sempre dalla parte della cittadinanza “boccio la tua per approvare la mia” [128]
-
''Dove Va A Finire Tutto Questo Amore?''... a Vaiano! [120]
-
25 novembre 2024 [101]
-
A che punto siamo con Neom? [101]
-
R1PUD1A la guerra Torneo di Burraco per EMERGENCY [96]
-
FATE PACE CON VOI STESSI [94]
-
Serena Sbrana: “Uso improprio del profilo istituzionale del Comune da parte del Sindaco Ghimenti” [89]
-
Particella negativa! [88]
-
Il libanese Salam... [85]

Questa è la storia della vita di Morando Cinacchi, un migliarinese che Francesco Parducci, docente in Clinica oculistica conobbe in Santa Chiara dove Morando lavorava. Dalla passione del dottore per le storie di vita e quella di Morando per la pesca, nacque un gustosissimo libro: Dal canto del gallo al sotto del sole- Morando, nostalgia di un fiume, edito nel 1999 da Felici editore.
Un insieme di storie di contadini, di vita legata alla Casa Salviati, di amore e dolore, di pesci e di passerotti.
Ecco parte del capitolo “Le cee”
Cosa vuol sapere? quando cominciai a prendere le cee?
Quella volta sì che ebbi una torbata da mia madre!
Facevo la prima, avrò avuto sei anni. “Passano le cee" urlavano i contadini. Il mi` babbo era già partito con la ripaiola e la lanterna. Era già andato sotto il sole. Chiamo Ginetto e Idalgo. “Ragazzi si va anche noi‘?”
Ma di ripaiole non ce n’erano più. I grandi erano già andati tutti via. C’era la torba sul Serchio e la piena era già passata; il momento era quello buono. “E con cosa si pigliano?” “Ci penso io” dissi agli altri due. Andai in cucina e presi lo staccio della farina di granturco e lo staccai dal chiodo del muro. Era più piccolo di quello della farina bianca ma era più rado, avrebbe retto meglio la corrente. Un palo di acacia, bello diritto e pulito, di quelli che servivano per puntellare le piante, e due chiodi fatti dal fabbro.
Cosa dice? Se erano chiodi speciali?
Ma nemmeno per idea. I chiodi non si compravano mica in città. Li faceva tutti il fabbro. Belli e buoni ma per lo staccio erano troppo grossi. Quando provai a fermarlo in cima al palo, e già con le bullette lo avrei rovinato, mi si schiantò. Però reggeva sempre. Si prese la lanterna, il secchio che serviva per abbeverare le bestie nella stalla e via di corsa giù dall`argine, sotto casa mia, al camposanto. Io ero stato tante volte col mi’ babbo e sapevo come si faceva. Ma lui ne prendeva qualche etto alla volta con la ripaiola; con quello staccino era già una pesca buona quando se ne tiravano su venti o trenta. Piano piano, poco alla volta, se ne fece due o tre chili. E poi si tornò a casa.
Se s’era soddisfatti della pesca?
Su per l’argine si cantava a squarciagola che credo ci sentissero anche dalla fattoria. Ma ci sentì anche mia madre.
Appena sbuco sull’aia te la vedo sulla porta tutta nera contro la luce del lume a petrolio con le mani sui fianchi. Sa, quella era la sua posizione di battaglia: quando ci aspettava così eran guai.
Caso volle che aveva cercato lo staccio per fare la polenta per la colazione del giorno dopo. Cerca, fruga, ma lo staccio dov’è, fino a che mia sorella dovette dire “l’ha preso Morando”. Lei lo sa bene che quanto più uno aspetta e più gonfia. Mi fece schiodare lo staccio dal palo, tira con le tenaglie, ma svelto con quella lì sopra sempre con le mani sui fianchi, mi pareva enorme; ogni tanto davo un’occhiata la vedevo "torba". Era proprio aria di buriana. Alla fine il chiodo venne via ma il legno dello staccio che era un po’ "schiantato" si aprì del tutto e cadde in terra. Mia madre lo prese con calma, aspettò che mi alzassi e poi come un fulmine, tanto che io svelto come ero, non ce la feci a scansarmi, me lo dette sul muso, con una sventola che me la ricordo sempre.
E poi sempre zitta prese la granata di saggina e sa, aveva voglia di correre per la cucina, lei sapeva che non ce l’avrebbe fatta a prendermi, noi bimbetti eravamo troppo svelti; ma lei ferma aspettava il momento giusto e poi lanciava la granata che ti colpiva sempre nelle gambe; non l’ho mai vista sbagliare.
Mi fermai tutto ammaccato, sapevo che era finito il castigo; dopo di che il solito: “ora, quando toma tuo padre, si farà i conti” come se di conti non se ne fossero ancora fatti. Ma più tardi lui tornò tutto contento con una corba di cee e mi dette soltanto due ceffoni.
Cosa dico, signor mio, che mio padre doveva essere una pasta d’uomo. Buono come il pane era, certo, ma se avesse assaggiato le sue botte non so se mi direbbe così.
Una volta, era domenica, andai con Idalgo e Ghigo a portare fuori nei campi i maiali. Si facevano uscire dal mandriolo battendo con la mano nel bussolo da sardine pieno di granturco. Per loro era un segnale. Si lasciava cadere qualche chicco via via che si camminava e loro dietro come canini, rufolando ci seguivano fine a dove si voleva noi. Poi si lasciavano fare e andavano a giro per i campi mangiando cicerbite e rosolacci. Si potevano lasciare anche nei campi di grano. Non sciupavano niente, cercavano solo quelle erbe lì. Però si doveva stare attenti che non sconfinassero nella terra dei vicini.
E noi ragazzetti si chiacchierava. “Ho trovato un nido di tortore”, “e io conosco due midi di colombacci”... “andiamo a vedere se sono da mangiare”.
Addio maiali.
l nidi erano per noi la "caccia" preferita a quell’età. Si conoscevano tutti e si facevano certi arrostì! Le cinciallegre poi tomavano sempre a covare negli stessi buchi dei tronchi. Si infilava la mano e si tastavano gli uccellini fino a che non erano giusti, belli grassi e impiumati.
Cosà dice che è roba dell’altro mondo?
Ma nemmeno per idea, era roba del mondo dei poveri! Lei non l’ha conosciuto e non sa cosa vuol dire!
S’andava su per i tetti col paniere e si alzavano le tegole piano piano. Sotto ogni tegola c’era un nido di passerotti. Si sceglievano con cura e si lasciavano quelli più piccoli per la volta dopo. Col paniere le dico e a volte si riempiva.
Il mio babbo non voleva, mica perché era male saccheggiare i nidi, ma perché, aveva paura che si spostassero i tegoli e si rovinasse il tetto. Ma quando c’era l’arrosto mangiava anche lui.
Allora, le dicevo, si va a "fare nidi", si torna con dei bei colombacciotti, si va a casa tutti contenti e davanti alla pertica dei cavalli ti vedo mio padre appoggiato ad un palo, buio, signor mio, come una notte di temporale. Solo allora ci vengono in mente i maiali.
Via di corsa per i campi, botte ai bussoli per chiamarli. Loro vengono, una lunga scia di granturco, ciao Idalgo, ciao Ghigo. Metto i maiali nel mandriolo e scendo la scala. Mio padre con la cintola in mano non fiata e aspetta che gli passi davanti.
Lei di certo pensa ad una cintola come la sua, fine, leggera, da città, che mi pare tiene più per eleganza che per reggere i pantaloni. Ma da noi le cinghie le faceva il "sellaio", sembravano "sottopancia" di cavalli, alte così e di cuoio duro alto mezzo centimetro. Si può immaginare le fibbie. E da questa parte mi picchiò alle gambe mio padre; ogni scalino una cinghiata, e dove batteva il ferro della fibbia portava via il pelo e la pelle.
Per quindici giorni tutto zoppo mi toccò andare alla farmacia, dove c’era il pronto soccorso, a farmi medicare dalle suore.
Questo era mio padre.
Le cee? Già, sono andato fuori dal seminato.
Vuol sapere se ne ho prese tante in vita mia?
Non ne parliamo nemmeno. Voglio raccontare solo questa per avere un’idea di cosa era il Serchio ai miei tempi.
Era Carnevale del 1921.
“Si va Morando a Viareggio” mi dissero alcuni ragazzotti che passavano. “Noi andiamo”
Io non ero nei campi perché, mio padre, pur grande lavoratore, ci faceva rispettare tutte le feste e tale era considerato il giovedì grasso. Poi pioveva che Dio la mandava. Avevo poca voglia di andare a Viareggio, anche perché, c’ero stato l’anno precedente ed avevo rimediato una "ciabattata" nella faccia da una signorina. E non era stata nemmeno colpa mia. Eravamo tre o quattro ragazzacci ed uno si era fatto troppo ardito stando dietro alla ragazza durante la sfilata dei carri.
“Quest’anno non ci vengo”. E dentro me pensavo di andare a fare il “porto” per le cee e la sera tentare la fortuna. ll porto per le cee era formato da un palo conficcato nel fondo del fiume a circa un metro dalla riva fermato a questa con del filo di ferro. Si metteva poi tra il palo e la sponda una quantità di terra mista a fasci di cannella di padule in modo da costruire una diga; l’acqua qui avrebbe formato una "riségola" dove le cee, che risalgono il fiume costeggiando la riva, trovando l’ostacolo, si sarebbero radunate. Volevo andare davanti a "Piaggerta", dove ora ha comprato il Mori.
La sera presi la ripaiola e un pezzo di arrosto di maiale che si conservava per l’inverno sotto lo strutto, un po’ di pane e del vino che avrebbe fatto comodo, oltre che per la sete, anche per dare un po’ di tepore durante la nottata. Dopo aver dato una mano al mi’ babbo nella stalla uscii di casa. Appena sull’aia vidi apparire una lanterna. Era Desiderio, un contadino che stava vicino a noi, gran "cecaiolo", che camminava con la ripaiola in spalla mogio mogio.
La luna era ancora in cielo ad un’altezza che per il sole si sarebbe detto "a una pertica". Pioveva.
“Allora Desiderio?Cee?"
“Nemmeno una Morando”.
“Io vado”.
“Guarda ho provato al porto dello Sbrana e al porto di Beppe ma non ne ho prese punte. O te dove l’hai fatto il porto?”
“Al rovaio, sotto la "vetricia".
“Vai, vai e che Dio te la mandi buona”.
Prendo anche la corba e la lanterna ma quando arrivo sul porto la luna aveva fatto capolino tra le nuvole e dissi tra me: La lanterna non l’accendo; tanto vengo via subito. Do una retata lungo il ciglio, tiro su la ripaiola e sento uno sfrigolio come se invece dcl retino avessi in mano una padella che frigge.
“O che saranno, gamberi?” Guardo bene contro la luna. ”Madonna mia, sono cee"! Metto subito il telone nella corba e le vuoto dentro il recipiente. Nel giro di mezz’ora riempio la corba. “E ora cosa faccio?” penso, poi vado lì vicino nel campo di Emilio del Cinacchi, un cugino di mio padre, dove aveva fatto la segale. Ne strappo un po’, ci pesticcio, faccio una specie di "culla". Rovescio la corba e torno a pescare. Non le dico quante ne presi.
Quando il passo delle cee stava diminuendo mi misi ad urlare, come si usava fare, per avvertire i contadini intorno. “Passa le cee!”
Era un atto di gentilezza anche se tutti i cecaioli urlavano sempre quando le cee non passavano più, dopo averle prese. Io lo feci in particolare per Mario Galigani, gran cecaiolo, che quella sera era rimasto in casa.
Non sapevo come fare a portarle via! Con la corba piena vado a casa e trovo, lì vicino al pollaio, il mio fratello Egidio che con la bicicletta tornava da far all’amore.
“Morando o quante cee hai preso? Hai la corba piena!”
“E bisogna andare a prendere quelle che ho lasciato al fiume”.
“O che ce n’hai dell’altre?”
“Vieni e vedrai”.
Si prende due bigonce che servivano per abbeverarci le vacche nella stalla, roba da venti litri l’una, e si va al campo del Cinacchi.
“Quante sono! O quante ne hai preso?”
“A retate ti dico, a retate”
A casa si empì la conca dcl bucato. Il problema venne quando si dovette "stenderle", perché, le cee, se si vogliono tener vive, non possono stare compresse in grossi recipienti. Si stesero in un granaio e mia madre mise in terra due lenzuola di canapa. Si empirono tutte e due!
“Che le mangiasti tutte Morando?”-
“Ma che dice! Mio padre lo chiamavano "quello del comune" perché distribuiva ai parenti e amici tutto quello che aveva in più. Si contentarono tutti. “Portale a Armando, portale a Beppe. Portale anche al Galigani, che stasera aveva sonno".
Quelle che avanzarono si portarono vicino alla concimaia ai polli”
“Ai polli? O che davate le cee ai polli?”
“Centinaia di volte ho governato i polli con le cee. E con i gamberi. Le anguille le davo all’anatre. Ma lo sa che con le fascine ne prendevo a secchiate?
Questo tipo di pesca lo inventai io. Vicino al ponte di Migliarino, sull’Aurelia, trovai una fascina sott’acqua e quando andavo la notte col "foone" vedevo sempre delle anguille proprio lì intorno. Io pensai che dentro le fascine ci fosse del mangiare.
Una sera ero con Giuliano e gli dissi “O Giuliano si tira su la fascina e si guarda cosa c’è dentro?”
Dentro non c’era alcuna esca ma quattro o cinque anguille grosse cosi, guardi, tutte intorno al chilo.
Allora io zitto, zitto, faccio una decina di fascine e le metto nel fiume legate con una corda fermata ad un ramo. Malo sa che tutti i giorni c’erano dieci—dodici chili di anguille? Aveva voglia di essere "del comune", ne avanzavano sempre! Ecco com’è che decisi di darle alle anatre.
Nelle fascine ci trovavo poi sempre i gamberi, a secchiate. Li portavo vicino alla concimaia dove raspavano le galline e cosi non li buttavo via.
Un giorno mi vide Mario Galigani che era lo zio dell’ultimo autista di S. Rossore....
Il resto della storia dei gamberi ve la racconto la prossima volta, ora restate a rimuginare sulla vita delle cee e del nostro Morando!
 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO5/7/2016 - 16:29
AUTORE:Un secchio pieno. Ne aveva pescato un secchio pieno di quelli della vernice. Dal muraglione di bocca di serchio, le piccole spigole sotto misura, venivano alla canna come non si era mai visto.
Era da ricordargli tre cose. Primo che un giorno quelle spigolette sarebbero diventate bestioni enormi, molto divertenti da pescare. Secondo, che più bono dei carciofi fritti, c'è solo i carciofi fritti di mi madre. Terzo, che si sarebbe dovuto vergognare... E poi me ne sono andato con l'amaro in bocca.
5/7/2016 - 10:33
AUTORE:.
4/7/2016 - 8:32
AUTORE:E poi se si aveva fortuna qualcuno ci mostrava la "mazzacchera"..
Ho provato di recente a costruire qualcosa per i figli e i nipoti. È rimasto lì.. Il tecnologico attira di più, non c'è dubbio.
Riguardo a dove si è sbagliato. Forse bisognava lottare di più quando era il momento? Dico sempre che non è mai troppo tardi. Ma mi sembra che ci si crede in pochi....