
Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.
Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.



Il primo fu il .....










-
Oggi e i colori. [2]
-
25 aprile 2025 [3]
-
ANCHE A PASQUA SI APRONO GLI STADI. SI GIOCA ANCHE LA SERA DEL SABATO SANTO E LEGGETE LA CITTA' CHE GIOCA [4]
-
Pensieri. [2]
-
Attenti al lupo. [1]
-
L’allineamento del Pd di Schlein alle posizioni di M5s e Avs, più che a una convergenza, somiglia a una conversione [1]
-
BUONA PASQUA [2]


di Valdo Mori







per Fiab Pisa




Ma è inevitabile
Chiudo gli occhi per non guardare
Ma quella livida rigidità
appare scompare riappare
Io ti .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
Agrifiera 2025 inaugurata: il programma del 24 e 25 aprile [318]
-
Agrfiera: gli appuntamenti necessitanti iscrizioni o prenotazioni [216]
-
Successo nazionale per il libro di Alessandra Favati, "Il coraggio tra i fiori di ortica" [206]
-
Rimozione tigli, intervento del Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori [171]
-
25 aprile 2025 [164]
-
"25 Aprile: la memoria è impegno civile" [154]
-
La sorpresa del e nel “l’uovo di Pasqua”. [135]
-
Attenti al lupo. [131]
-
ATTIVATO IL SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO PER AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA FIERA [111]
-
In programma anche la tradizionale biciclettata per le alunne e gli alunni della scuola media [105]
-
Il mio ricordo di Papa Francesco [104]
-
Petalo bianco-L’illusione degli anti Meloni di acchiappare voti con un partitino cattolico [102]
-
E' morto papa Francesco [101]
-
Un grande risultato per la FP Cisl di Pisa alle elezioni per il rinnovo delle RSU [97]
-
L’allineamento del Pd di Schlein alle posizioni di M5s e Avs, più che a una convergenza, somiglia a una conversione [96]
PIGGELLO
Lett: nc.
Piggello si chiamava quel piccolo rametto di vite con attaccate alcune pigne d’uva che era costume regalare ai partecipanti alla vendemmia da portare a casa la sera, quando questa era terminata.
Era un dono simbolico poiché in campagna le viti erano a portata di mano e chiunque poteva, con il dovuto rispetto della vite e del contadino, coglierne quando ne voleva. Era un modo semplice per ringraziare i partecipanti, di solito parenti, amici o vicini arruolati per l’occasione. Non esisteva una forma di pagamento per la prestazione, sia perché vi era reciprocità d’aiuto, sia perché la vendemmia veniva vissuta come una festa collettiva.
Si iniziava presto al mattino ed ogni partecipante si presentava munito del proprio paio di forbici od altro attrezzo tagliente. Di solito erano forbici da pota, quelle forbici tutte di ferro tenute chiuse infondo con un piccolo cappio di cuoio, ma anche le normali forbici da cucina andavano bene. Ognuno prendeva posto da una parte di una filata e cominciava a tagliare le piggie dalle viti riponendole in un secchio, in una cassetta di legno o in cestini di vimini realizzati appositamente.
Man mano che queste si riempivano gli uomini passavano e le svuotavano in recipienti più grandi e capaci, chiamati bigongie. Queste erano dei grossi contenitori di legno fatti a doghe, come le botti, e tenute insieme da cerchi di ferro. La loro robustezza si rendeva necessaria poiché le pigne d’uva venivano schiacciate (pigiate) in questi recipienti con un robusto bastone, più grosso in testa, che prendeva il nome di pigio.
Le bigongie servivano a trasportare l’uva pigiata e ridotta in poltiglia in un grande contenitore che prendeva il nome di tino, dove poteva essere ulteriormente schiacciata (con i piedi, con grandi risate di ragazze e fanciulli) oppure direttamente nelle botti.
Mentre il tino era un contenitore aperto le botti avevano un’apertura molto piccola e per svuotarle senza perdita di prodotto si usava una specie di grosso imbuto detto tremoggia.
Con il nome di tremoggia si indicava anche un altro grosso imbuto, stavolta però fornito di un ingranaggio a manovella con due ruote dentate contrapposte, che serviva a schiacciare l’uva prima di metterla definitivamente nella botte.
La botte non veniva riempita completamente fino all’orlo perché l’uva, ribollendo e sviluppando una grande quantità di gas, avrebbe fatto traboccare il mosto. Veniva lasciata riposare aperta per circa sette-otto giorni tuttavia, mattina e sera, il contadino doveva pigiare e rimestare il contenuto controllandone la fermentazione e favorendo così la sua maturazione in vino. Lo zucchero contenuto nell’uva in questo lasso di tempo infatti subiva una prima trasformazione in alcool. Avveniva quella che in termine tecnico è chiamata “fermentazione principale” che aveva luogo naturalmente, senza l’aggiunta di alcun fermento, poiché questi erano normalmente contenuti nelle bucce e nei raspi dell’uva.
L’ultimo giorno prima della svinatura l’uva non veniva pigiata per fare in modo che la parte liquida in fondo alla botte e quella solida in cima rimanessero separate. A questo punto la botte si poteva incannare, cioè introdurre in basso per mezzo di un mazzolo (un grosso martello di legno, con due cerchi di ferro ai lati) una canna di legno o di ottone munita di rubinetto. Aperto il rubinetto ne usciva il mosto, non ancora vino maturo, che veniva travasato in altre botti. Si rimuoveva poi la porticina in basso chiamata mezzulo e si raccoglieva tutto il resto composto di bucce e raspi, che veniva poi passato nella strettoia, ed aggiunto al mosto nelle botti.
In caso di uve e di vini di grande pregio i contadini erano soliti mettere in botti diverse il mosto naturale e quello strinto, per avere una migliore qualità del prodotto.
Il vino rimaneva nella botte dai quindici ai trenta giorni, poi veniva governato e la botte definitivamente sigillata. Il governo del vino consisteva nell’aggiungere nella botte già piena una piccola quantità di uva spippolata, cioè composta di soli acini schiacciati. Questo serviva a dare un’ultima piccola spinta a quella fermentazione, stavolta “secondaria”, che conduceva, nell’arco di tre-quattro mesi, alla maturazione alcolica del vino. In tutto questo tempo la botte rimaneva sigillata, spesso addirittura murata con del cemento, con alla sommità il bollitore in vetro che permetteva di controllare visivamente l’andamento del processo interno.
Quando si pensava che il vino fosse pronto si poteva controllare mediante lo zipolo. Questo era un piccolo cuneo di legno che veniva inserito in alcuni fori presenti a diversa altezza nella parte anteriore della botte. Togliendo lo zipolo usciva un piccolo fiotto di vino che veniva raccolto in un bicchiere ed assaggiato per controllarne la maturazione e la qualità. Esistevano anche degli zipoli più sofisticati, fatti di corno con un piccolo rubinetto chiuso con un tappino, ma nella campagne erano utilizzati esclusivamente quelli artigianali, di semplice legno.Quando si giudicava che il vino fosse pronto si incannava nuovamente la botte e si distribuiva in damigiane di vetro dove poteva essere conservato anche per molto tempo. La conservazione si otteneva versando alla superficie del vino, al collo della damigiana, un velo di olio di paraffina incolore ed inodore che aveva il compito di isolarlo dal contatto con l’aria. Si chiudeva con un tappo di sughero e sopra si posizionava un tappo di terracotta o anche un semplice bussolotto di latta per proteggere la damigiana e il sughero dai topi, frequentatori abituali delle cantine.
I topi erano combattuti dal contadino con lo spargimento continuo di sostanze velenose ma anche con la costante presenza dei gatti, i quali avevano accesso garantito alle cantine tramite una piccola apertura ricavata in un angolo dell’uscio, detta appunto gattaiola.
Vuotata dal vino la botte veniva ripulita, lavata, avvinata (passata cioè con una modica quantità di vino buono), lasciata asciugare aperta per un giorno o due ed infine chiusa, ma non prima di averla disinfettata bruciandovi dentro una piccola quantità di zolfo.
In fondo alla botte, una volta svuotata, rimaneva un deposito di colore rossastro, detto gruma, che veniva buttato.
Le vinacce, invece, non avevano ancora finito il loro percorso ed avevano un’ ulteriore destinazione. Potevano essere distillate, con mezzi artigianali, per farne della grappa oppure immesse di nuovo nella strettoia e strinte una seconda volta. Se ne ricavava un vino torbo, qualitativamente inferiore al precedente, ma ugualmente utilizzabile magari dopo averlo fatto riposare e schiarire in una piccola botte. Anche questo naturalmente andava governato.
Le vinacce, così spremute, non venivano ancora buttate ma il contadino le metteva a mollo in acqua per una quindicina di giorni e ne ricavava il vinello, un liquido roseo con l’uva rossa o nera come si diceva, poco alcolico, che con l’aggiunta di un buon governo acquistava un po’ di colore ad anche un piacevole frizzantino.
In via delle Pratavecchie lo faceva Curzio dell’Antonelli che aveva le strettoie e andava a stringe da tutti i contadini vicini che avevano l’uva.
A questo punto finalmente le vinacce, esauste, venivano date in pasto ai polli che erano ghiotti dei vinaccioli.
E lo zucchero? Nessun contadino ha mai ammesso di averlo utilizzato per il proprio vino! L’aggiunta di zucchero per aumentare il tenore alcolico del vino è comunque solo una frode fiscale, (aumentandone la gradazione ne aumenta il valore economico), ma non comporta nessun tipo di rischio per la salute essendo lo zucchero un componente naturale dell’uva. Dalle damigiane, come passaggio finale, il vino finiva nei fiaschi. Il fiasco, caratteristico recipiente di vetro soffiato, è stato inventato in Toscana ed è stato sempre sinonimo di vino toscano. Prima del XVIII° secolo il vino veniva trasportato esclusivamente in botti ma, a partite dal 1710, diversi inconvenienti ne consigliarono la spedizione in fiaschi. Il Villifranchi nella sua Oenologia Toscana dice “la botte non si può facilmente assaggiare e perché di sua natura succia una parte di vino, e resta così scema, guasta e rende inferiore il rimanente (…) laddove i fiaschi possono più facilmente compartire un saggio del vino appartenente ad una data commissione e lo mantengono senza diminuzione alcuna…”.
I fiaschi venivano impilati su barrocci, talvolta in miracoloso equilibrio, oppure trasportati con appositi panieri intrecciati di vimini, capaci di trasportare fino a cinque fiaschi ciascuno.Il fiasco ha almeno sei secoli di vita e si ha notizia che un certo Ser Niccolò da Gambassi, bicchieraio, aveva già nel 1454 una fornace a Figline Valdarno ove produceva anche fiaschi di vetro.Il successo del fiasco era anche dovuto alla sua leggerezza, solo un paio di etti per quello da due litri, e alla sua capacità di reggersi in piedi su qualunque superficie, anche nei campi. Il suo rivestimento poi lo rendeva resistente agli urti e proteggeva contemporaneamente il vino dal sole.
Il rivestimento però, così utile e caratteristico, sta diventando causa stessa della crisi che questo contenitore sta attraversando.Il costo dell’impagliatura, a mano, con aghi, con erbe palustri (sala, biodo, stiancia) sta diventando molto elevato ed è aggravato oltretutto dall’impossibilità del recupero del prodotto già utilizzato. La pulitura del rivestimento risulta imperfetta e se un contadino non si curava di mettere in tavola un fiasco con la paglia macchiata e sfilacciata, questo non è accettabile nel caso di un prodotto ad uso commerciale.
Il vino ed il suo utilizzo ci riporta ad un gustoso aneddoto riguardante il compianto Giocche.
Aneddoto.
Giocche ed ad alcuni amici si ritrovano una sera a cena dal Carnasciali. Dopo essersi sistemati a sedere ed avere consultato il menù si avvicina il cameriere con il blocchetto per le ordinazioni. La prima cosa che viene servita, di solito, è da bere in attesa delle ordinazioni.
“Buonasera signori….. vino?” “A volontà!” propone subito Giocche. “Benissimo e…acqua!” Un silenzio imbarazzato, poi si sente ancora la voce di Giocche: “Mah, portane una bottiglia …. in caso d’incendio!!”
PILLACCHERONE
Lett: PILLACCHERA. [Schizzo di fango attaccato ai panni].
Il verbo ha mantenuto questa origine: “guarda ‘ome ti sei ‘mpillaccherato!” : guarda come ti sei schizzato di fango! Pillaccherone ha assunto invece il diverso significato di bighellone, vagabondo, sfaccendato.
“Un fa tanto ‘r pillaccherone!”, “se’ proprio un ber pillaccherone!”
erano modi di dire comuni rivolti ad una persona un po’scansafatiche, una piccola esortazione con un modesto significato offensivo.
Spillaccherare, che è la forma verbale del termine, poteva assumere, anch’esso, due significati diversi:
in “’un ni stà tanto a spillaccherà!” manteneva il senso di perdere tempo, bighellonare mentre in “cosa c’ avete da spillaccherà?!” il verbo assumeva il significato di spettegolare, malignare, sparlare.
Foto.
Trasporto del vino in fiaschi, inizio 1900






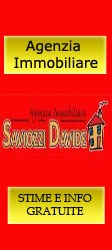






 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO