
Un paese che amo, il paese della mia mamma.Anche ora quando vado a RIPAFRATTA sono la figlia della "Cocca".
Un paese con una storia importante che conserva vestigia di grande rilievo.
Un paese rimasto inalterato nel tempo, non ci sono insediamenti nuovi, potrebbe essere il set di film d'epoca perché anche le case, le facciate conservano la patina del tempo.Un paese che è ancora comunità.



Il primo fu il .....










-
Abbattimento dei 35 tigli sulla Provinciale Ripafratta-Cerasomma [1]
-
Landini È ossessionato dal job act e da Renzi [2]
-
Da molto tempo dovevano essere fermati, spero ci sia un inferno abbastanza adeguato alla loro malvagità [3]
-
Siamo cresciute insieme: 4 alberi in ricordo di Francesca, Paola, Valeria e Virginia [2]
-
Il Molino Grassotti di Paola Gavia [1]
-
CHE PIACCIA O NON PIACCIA MATTEO RENZI E’ UNO STATISTA [3]
-
Le 17 regole della propaganda russa. [1]

di Valdo Mori



di Valdo Mori





San Giuliano Terme, 24 aprile




viene considerato un inevitabile passaggio
alla fine del faticoso viaggio
vissuto da tutti con coraggio?
Il .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
AGRIFIERA 2025: PRESENTATA LA 115ª EDIZIONE [271]
-
Laghetti di Campo: una nuova istanza per un grande impianto fotovoltaico di una ditta privata [168]
-
I giochi di cortile. [145]
-
PAPPIANA VINCE VS "ANGELO BELLANI".E' SALDAMENTE AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. RETI DI PAVOLETTONI E STABILE [140]
-
Siamo cresciute insieme: 4 alberi in ricordo di Francesca, Paola, Valeria e Virginia [136]
-
PONTASSERCHIO VINCE IL DERBY VS MIGLIARINO.SKHURTI CAPOCANNONIERE CON 25 RETI. I VECCHIANESI AI PLAY OFF [122]
-
Al via le operazioni di pulizia della spiaggia a Marina di Vecchiano [121]
-
La nuova eroina antikasta si chiama Rita De Crescenzo, cantante, tiktoker e influencer napoletana. [119]
-
CHE PIACCIA O NON PIACCIA MATTEO RENZI E’ UNO STATISTA [116]
-
Guarda la Natura che ti guarda! [115]
-
Aldo del Gratta ed il suo nuovo romanzo "Averno" [114]
-
Abbattimento dei 35 tigli sulla Provinciale Ripafratta-Cerasomma [102]
-
Le 17 regole della propaganda russa. [99]
-
Da molto tempo dovevano essere fermati, spero ci sia un inferno abbastanza adeguato alla loro malvagità [93]
-
POSTEPAY PRESENTA AL NETCOMM FORUM IL PROPRIO ECOSISTEMA PER UNA “GREAT SHOPPING EXPERIENCE” [86]

LE ORATE
Ancora oggi non ho ancora capito che cosa volesse dirmi il Davini quando sputava con la lingua premuta sul palato e contro i denti superiori, facendo schizzare la saliva dalla fessura centrale fra i due incisivi.
Non che non capissi le parole dette nel momento dell'azione dimostrativa perché non credo proprio che si possa sputare e parlare, ma non capivo proprio il senso del discorso quando mi diceva che sarei stato in grado di fare tante altre e più importanti cose, al momento che fossi stato capace di sputare come lui. Forse si riferiva allo "schizzo" della maturità sessuale, oppure al fatto che a sputare così era lui che era adulto e quindi con più esperienza, ma io provavo e riprovavo, anche se non immaginavo a cosa in fondo servisse, con il solo risultato di sbavarmi il mento e il petto e far ridere gli altri pescatori riuniti sotto un ombrello d' incerato (non pioveva di giugno ma il sole picchiava forte) e qualche frasca, sulla spiaggia di S. Rossore.
C'eravamo fin dall'alba di ogni domenica, fra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, a pescare le orate e quasi tutti nel medesimo posto. Il mare è grande e lunga la spiaggia ma, pareva impossibile, tutti ci ritrovavamo a lanciare in un breve tratto di costa, consapevoli di buttare tante esche per non fare allontanare di molto dalla zona il branco dei pesci che avevano trovato lì la pastura buona, ma anche con il risultato, a volte, di causare un grande groviglio di fili e piombi.
E allora giù moccoli ed accidenti, perché in quel caso, stranamente, l'accalappiato era sempre quello che in quel momento stava prendendo qualcosa.
"Accidenti a te po pò di peoro!"
"Me lo fai apposta nato di 'ane"
"Ma se ‘un sai lancià’, cosa ci vieni a ffà’ ar mare? Stai ner campo!"
E più era saldo il vincolo di amicizia fra quei pescatori sfegatati, più erano grossi gli improperi e le urla.
Mio padre però li batteva tutti, amici o no!
Se poi a combinare il malfatto ero stato io, allora mi conveniva fare a piedi i 20 chilometri che mi separavano da casa, e cercare conforto da mia madre che a sua volta pregava il cielo che mio padre tornasse a casa con qualche pesce perché‚ altrimenti, sarebbero stati guai per tutti, specialmente se a prendere di più era stato un rivale.
Si usavano canne lunghe 5 metri e più, in solo due o al massimo tre pezzi, con il calcio fatto di canna comune e il cimino di bambù molto robusto, corredati di quattro o cinque anelli di ferro per lo scorrimento del filo e legati alla canna con dello spago, poi verniciato, perché non si sciogliesse. Mio padre, come del resto quasi tutti, si faceva da sé le canne da pesca usando a volte pezzi non molto diritti ma forti e allora la sera vi era un lavoro straordinario: accendeva una candela e sulla fiammella passava e ripassava il pezzo ricurvo della canna dopo averlo imbevuto di olio d'oliva finché, con ripetuti e forti massaggi, il vegetale si ammorbidiva e raddrizzava. Dopo tale trattamento le canne di mio padre prendevano una caratteristica che le distingueva fra tutte le altre della spiaggia perché erano quasi tutte affumicate, dato che a lui piacevano quelle vecchie canne prese dalla riva del Serchio, canne di due anni che avevano dovuto lottare con le piene del fiume e con tutte le avversità atmosferiche e si erano temperate ai soli e alle lune, a scapito della loro bellezza e longilineità. Infatti le canne belle dritte che erano nate su un buon terreno, al riparo della furia delle acque, erano “grosse ma burrone" diceva lui e con il passare del tempo non avrebbero retto gli sforzi dei lanci.
Quando mio padre lanciava era uno spettacolo!
I cento metri di filo del '35 o '40 che erano in quei mulinelli marca "Alcione" o "Cigno" che vendeva solo il Maccari a Pisa, venivano tutti fuori dalla bobina, tirati da un piombo di un etto ed anche più; piombi fatti in casa, fusi da pezzi di tubo di scarico di vecchi lavandini, usando come crogiolo un pentolino preso a mia madre e non più rivoluto, tanto puzzo in cucina e stampini fatti col gesso.
La tecnica del lancio è semplice: apri l'archetto del mulinello, stendi tutta indietro la canna e la spingi in avanti a frusta, lasciando andare il filo tenuto fermo fino a quel punto con il dito indice.
Sembrava facile, ma le uniche volte che a me il piombo andava lontano era quando si udiva uno schiocchetto in aria prodotto dalla rottura del filo per qualche intoppo e allora il peso, libero dall'attrito del nylon, partiva come un proiettile meravigliandomi e facendo invelenire mio padre per la perdita di un “altro” piombo.
C'era con noi il Dottor Lopez, grande pescatore di mare tanto che in San Rossore c'è un luogo che ancora oggi si chiama "buca Lopez", poi il nostro padrone di casa di Metato, Bruno del Coli, un pisano (quel tal Davini), un paio di migliarinesi e pochissimi altri, ma sempre gli stessi. Bisognava essere al mare all'alba perché le ore migliori erano quelle quiete, quando spirava una leggera brezza da terra, ma per noi era un problema arrivare in tempo per le prime luci del giorno perché la spiaggia era distante da casa più di 20 chilometri e dovevamo fare anche i vermi per le esche in Fiume Morto, perché quelli “compri” ammarcivano subito. Avevamo solo un Mosquito e me sulla canna, le borse con l'attrezzatura e il mangiare, il fascio delle canne che "se caschiamo è meglio che ti tronchi un braccio te piuttosto che un cimino", la vanga per gli ombrini e la strada lunga e pericolosa prima sterrata e poi oltre il Marmo tutta zigzag, fra pini e querce nel mezzo alla pineta.
C'era, subito passato il cancellino del Marmo, una strada diretta al mare che passava sull'argine e che ci avrebbe portato alla spiaggia in breve, ma era molto pericoloso viaggiare in due sullo stesso mezzo e far andare la ruota anteriore proprio nella fossettina scavatasi nel centro del viottolino perché bastava una leggera oscillazione e si faceva un ruzzolone dalla scarpata.
Altro motivo della scelta della via più lunga per il bosco era che dovevamo andare, prima che al mare, a cercare le esche lungo la riva di Fiume Morto, verso la foce dove nel fango si potevano trovare gli ombrini e poi a corsa verso Bocca di Serchio, dove c'erano i posti di pesca migliori, buche e avvallamenti fra le secche e la riva.
Lì cominciavamo a saggiare le zone lanciando una canna molto fuori e una più vicina per vedere se le orate passavano sotto costa o più a largo e, alla prima tocca, tutti allora a lanciare sulla stessa direzione che il momento del passo, e quindi della mangiata, era preciso e breve.
Se le orate passavano vicine, allora sia io che gli altri potevamo sperare di prenderne qualcuna, ma se invece il branco era fuori allora solo mio padre poteva prenderle, perché nessun altro lanciava lontano come lui. A questo punto era tutto uno spogliarsi da camicie, pantaloni e scarpe e i pescatori mezzi nudi sfidavano le onde entrando in acqua anche fino al petto per guadagnare metri preziosi sul lancio perché quelle belle ma difficili bestie, se avevano deciso di pascolare in quella fascia, non c'era esca che potesse farle spostare da quella linea. Bisognava quindi lanciare in quel punto preciso, a monte o a valle non importava, perché i pesci seguivano o risalivano la corrente sud-nord della nostra costa, ma l'importante era la distanza dalla riva.
Se si aggiunge poi il fatto che la pesca delle orate va fatta con il mare agitato, allora si capisce il perché l'immersione nell'acqua fredda e mossa per fare i lanci lunghi era rimandata a quando non c'era quasi più niente da perdere o da prendere.
Capitava infatti a volte che arrivasse un cavallone quando il pescatore era girato a vedere il cimino nell'attimo prima del lancio ed allora vedevamo sparire nella schiuma canna e cannista e le risate peggioravano la situazione, oppure il pescatore, dopo essersi guardato alle spalle, si girava in avanti pronto allo scatto e prendeva in faccia sette tonnellate di mare e un groviglio di fili.
Nel branco delle orate capitava a volte, alla fine dell'estate, qualche pesce diverso dai soliti e che, come le cose strane e mai viste, venne chiamato dai nostri: "pesce americano", come se con il termine "americano" fosse spiegato così il mistero della provenienza.
Erano lecce voracissime e sempre affamate di qualsiasi esca, ma che inspiegabilmente, benché i pesci abboccassero bene, solo pochissimi arrivavano a riva. Dopo una breve e forte lotta, all'improvviso si annullava il tira e molla, come se si fosse strappato il filo, ma non erano rotture bensì tagli netti poco sopra l'amo. Le indagini fatte dettero la colpa delle perdite ai denti delle lecce che erano così affilati, tanti e minuti e le mascelle dei pesci così forti e muscolose, che il filo di nylon veniva tranciato anche se robusto e di grosso diametro. Le poche lecce prese erano quelle che avevano ingoiato l'esca fin nello stomaco e il dolore dello sforzo per liberarsi faceva tener loro aperta la bocca e salvare il filo. Erano tutte leccette sul chilo, ma la loro struttura ovale e affilata rendeva le loro tirate forti e forte la lotta per spiaggiare il pesce.
Quando il giorno dopo la pescata, dopo aver mangiato pesce a sazietà, andavo in giro per il paese cercando di vendere il superfluo, erano in molti a meravigliarsi che quella volta non avessi anguille ed era molto difficile far cambiare gusto ai metatesi. Solamente chi era stato in città al mercato qualche volta, riconosceva il valore di quelle magnifiche orate e, avendo paura che anche io chiedessi cifre come i banchi di Piazza delle Vettovaglie, faceva svelto l'offerta di un pollo o un coniglio, che per quella famiglia forse erano come i pesci per la mia.
E così, ambedue contenti per l'affare fatto, reputando che anche quella volta la fregatura era stata data e non presa, si rientrava e ritornava a casa, assaporando già nella mente quello che il giorno dopo si sarebbe dato al palato.
A volte si tiravano su strani e sconosciuti pesci, altre invece non si riusciva nemmeno a sapere se erano veri, o cosa facesse piegare le cime delle canne fino sull'acqua, per una e una sola toccata. L'immaginazione allora andava da tre chili a venti ed anche più, quando fra tutti si cercava di strappare il moncone di lenza rimasta a svolazzare alla brezza marina. La verificata robustezza del nylon che non si rompeva neanche alla trazione dei più robusti, ma che recideva invece la pelle delle mani, autorizzava il più fantasioso a riferire al bar la sera che il pesce scappato era quasi 25 chili e il giorno successivo, per il ponce di dopo pranzo, aggiungere anche una pinna scura alta 20 centimetri e di nuovo, alla partita a carte della sera, una coda che sembrava quella di un tacchino.
Il Serchio non ammetteva bugie, dai ponti al mare era un canalone conosciuto, stretto nell'Oncino tanto da far lasciare sulle "cascie" di San Rossore il cucchiaino che si lanciava troppo forte dalla parte di Migliarino, battuto da lenze e tramagli, fascine e bertibelli, nasse e bilancine. Tutto quello che ci viveva era stato preso prima o poi dai Giorgi o da Ottorino, da mio padre o da Bagarana, ma il mare era sconosciuto e poi era "grande".
A quello di Cascina che lo vide per la prima volta e che disse, sbarrando gli occhi e con un qualcosa che gli stringeva il petto: "Madonna mia, quant'acqua!",
l'amico che era già stato una volta con il prete ad una gita a Castiglioncello dodici anni prima, rispose:
"E 'un è mia nulla! Tu vedessi ‘vella e c'è sotto!"






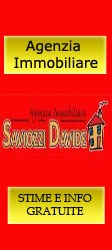





 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO