
Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.
Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.



Il primo fu il .....










-
Oggi e i colori. [2]
-
25 aprile 2025 [3]
-
ANCHE A PASQUA SI APRONO GLI STADI. SI GIOCA ANCHE LA SERA DEL SABATO SANTO E LEGGETE LA CITTA' CHE GIOCA [4]
-
Pensieri. [2]
-
Attenti al lupo. [1]
-
L’allineamento del Pd di Schlein alle posizioni di M5s e Avs, più che a una convergenza, somiglia a una conversione [1]
-
BUONA PASQUA [2]


di Valdo Mori







per Fiab Pisa




Chi dice che fosse il suo sorriso
Di sicuro era un uomo carismatico
Capace di comunicare con la gente
Capire e farsi .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
Agrifiera 2025 inaugurata: il programma del 24 e 25 aprile [275]
-
PONTASSERCHIO VINCE IL DERBY VS MIGLIARINO.SKHURTI CAPOCANNONIERE CON 25 RETI. I VECCHIANESI AI PLAY OFF [237]
-
Agrfiera: gli appuntamenti necessitanti iscrizioni o prenotazioni [208]
-
Successo nazionale per il libro di Alessandra Favati, "Il coraggio tra i fiori di ortica" [203]
-
ANCHE A PASQUA SI APRONO GLI STADI. SI GIOCA ANCHE LA SERA DEL SABATO SANTO E LEGGETE LA CITTA' CHE GIOCA [187]
-
Rimozione tigli, intervento del Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori [166]
-
25 aprile 2025 [157]
-
BUONA PASQUA [153]
-
"25 Aprile: la memoria è impegno civile" [150]
-
La sorpresa del e nel “l’uovo di Pasqua”. [131]
-
Attenti al lupo. [128]
-
Colpo del Comune nel contenzioso contro il grande impianto fotovoltaico del Brennero [125]
-
Circolo giovanile ARCI Nodica [118]
-
ATTIVATO IL SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO PER AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA FIERA [107]
-
Il mio ricordo di Papa Francesco [102]
Cultura e società 25 Aprile 2025
Di sicuro non era il 25 aprile 1945, doveva essere uno dei giorni immediatamente successivi, quando via via tutto il Nord venne liberato dalla presenza dei tedeschi. Ma ricordo bene che mia madre venne a prendermi a scuola – così come fecero molti altri genitori – per portarmi nella piazza principale di Canelli in Piemonte, dove allora vivevamo. E dove avrebbe parlato il Comandante Rocca, il capo dei nostri partigiani. Nel mio ricordo, fiabesco, è rimasta l’immagine del Comandante Rocca come se fosse non su un palchetto, ma sull’albero principale della piazza e di lì si rivolgesse a tutti noi. Ci disse che la guerra era finita, che avremmo costruito insieme una nuova Italia e pronunciò le parole che negli anni successivi sarebbero diventate la leva più potente verso l’unità europea, “mai più guerre fra noi”.
Fu un discorso breve, ma in ciò che ci disse erano racchiusi i due legati, i due grandi legati, che la Resistenza ci avrebbe lasciato. Il primo è quello di averci evitato il destino che ebbe allora la Germania, fornendoci una classe dirigente per la nuova Italia che gli alleati avrebbero riconosciuto, riconoscendole il diritto di guidare la transizione sino ad organizzare una Assemblea Costituente, che ci avrebbe dato, in piena e sovrana autonomia, la nostra Costituzione (tante volte mi è capitato di farlo notare a chi dice di riconoscersi nella Costituzione, ma di non condividere la Resistenza). Non so se il nostro Rocca ne era consapevole, ma di una tale consapevolezza si trovano comunque le tracce. Basta leggere, ad esempio, la Relazione sulla propria attività della Giunta provvisoria di governo della Repubblica dell’Ossola (la si trova nel libro a cura di Aldo Aniasi, “Ne valeva la pena. Dalla Repubblica dell’Ossola alla Costituzione repubblicana”, Biblion Ed., 2024). In essa si legge che «a opera degli autorevoli testimoni si diffuse in Svizzera e negli altri paesi europei l’opinione che gli italiani, pur lasciati a sé soli, e in condizioni difficilissime, hanno tuttavia la capacità di vivere liberamente, ordinatamente provvedendo all’amministrazione del loro paese. Fu, insomma, una efficacissima propaganda di italianità…che ha contribuito a risollevare il nostro popolo nella considerazione straniera!». Sappiamo che non tutti gli alleati erano d’accordo su ciò che si venne decidendo. È nota la preferenza del Regno Unito, di Winston Churchill, per la continuità monarchica. Ma nessuno volle opporsi alle decisioni sovrane del popolo italiano, guidato allora dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, i partiti della Resistenza.
Il secondo legato, che arrivò a farsi sentire in tutta Europa, vissuto e animato da tutti coloro che di quella terribile guerra avevano subito le conseguenze, fu l’impegno a mettere i nostri Stati insieme, non più l’uno contro l’altro. I progetti di unità europea non furono un’invenzione del Secondo dopoguerra. Lo stesso Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941, deve molto alle analisi e alle proposte che Luigi Einaudi aveva già formulato nel 1919. Ma la Prima guerra mondiale, che pure aveva sollecitato Einaudi e altri a progettare l’Europa unita, non riuscì a creare la forza necessaria a rimuovere gli ostacoli che il nazionalismo opponeva alla radice stessa dei progetti europeisti. Tant’è che dopo di essa furono proprio i nazionalismi a prevalere, sino a portare alla Seconda guerra mondiale. Furono le tragedie immani che essa produsse a generare la forza che era mancata in passato. Era ancora il giugno del 1945 quando a S. Francisco si riunirono i “popoli delle Nazioni Unite decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra” e quindi ad “unire le nostre forze per mantenere la pace”. E nacque, appunto, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con l’ambizione di sottrarre agli Stati membri le decisioni sui conflitti armati, affidandole al suo Consiglio di Sicurezza.
Quella promessa le Nazioni del mondo non l’hanno mantenuta. Ma l’integrazione europea, nata in modo meno immediato e più laborioso di quanto fosse accaduto per l’Onu, la sua promessa l’ha invece mantenuta. Il suo vero atto fondativo è la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, con la quale la Francia propose di mettere insieme la produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio, facendo sì che “una qualsiasi guerra tra Francia e Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile”. Nacque su questa base la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, seguita poi dalla Comunità Economica Europea, sino all’attuale Unione. Una costruzione piena di limiti e difetti. Ma radicata e cresciuta quanto basta da avere cancellato la guerra reciproca fra quegli stessi Stati che, in passato, con le loro guerre avevano insanguinato il mondo intero.
C’è chi osserva che non è solo così nobilmente endogena la spinta che ha generato la costruzione europea. La prima assemblea degli europeisti, quella dell’Aja del 1948 non generò nessuna assemblea costituente europea. E per avviare l’integrazione europea ci volle la necessità degli Stati Uniti di schierare l’Europa, Germania compresa, come argine al comunismo nella ormai avviata guerra fredda. È vero, questa è una verità innegabile che ha avuto il suo peso. Certo lo ha avuto nello smuovere la Francia. Che piegò le sue propensioni sovraniste alle ragioni della integrazione solo quando percepì che la Germania era destinata a ritornare sovrana; e a quel punto era meglio che tutte le sovranità europee, compresa quella francese, fossero imbrigliate in una rete europea, per evitare quanto accaduto in passato.
La Dichiarazione Schuman è frutto anche di questo. Ma sarebbe ottusamente cinico non vedere che c’è di più, c’è la forza degli interessi, ma c’è anche la forza dei valori comuni, che via via emergeranno, sino a diventare in primo luogo diritti degli europei, all’inizio affermati dalla Corte di Giustizia europea e poi proclamati in una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; in secondo luogo l’insieme dei principi oggi racchiusi negli artt.2 e 3 del Trattato di Lisbona, che tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare e che sono imposti a qualunque altro stato, che intenda entrare nell’Unione.
Sarebbe ottusamente cinico ignorare tutto questo, non solo perché ha dimostrato di esserci e di avere una sua innegabile forza coesiva. Ma perché si tratta di un patrimonio comune europeo, presente a chi scrisse il Manifesto di Ventotene, a chi, a Camaldoli, scrisse un “codice” che sarebbe diventato la base della nostra Costituzione repubblicana, a chi, in Francia come, a suo modo, anche in Germania, progettò il futuro costituzionale dei due paesi. Era il patrimonio che nutriva i tanti giovani i quali, pur potendo rimanere immersi nelle loro attività, decisero di lasciarle e di imbracciare le armi. Come Giaime Pintor, che mirabilmente lo scrive nella sua famosa ultima lettera al fratello: «Musicisti e scrittori dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti. Vent’anni fa la confusione dominante poteva far prendere sul serio l’impresa di Fiume. Oggi sono riaperte agli italiani le stesse possibilità del Risorgimento. Quanto a me… non ho mai apprezzato come ora i pregi della vita civile e ho coscienza di essere un ottimo traduttore e un buon diplomatico, ma secondo ogni probabilità un mediocre partigiano. Tuttavia è l’unica possibilità aperta e la accolgo”.
Questa, dunque, fu la Resistenza e questa la Liberazione che ci dette. Tenerne vivo il legato, nelle condizioni difficili di oggi, è una missione che rimane.
Foto scattata da Livio Bobbio il 23 aprile 1945 a Canelli, sul terrazzo che si affaccia sul cortile delle ex scuole G.B. Giuliani (Archivio Giamelli-Bobbio). L'immagine di copertina che ritrae Giuliano Amato nel 2022 è di Wikimedia Commons.



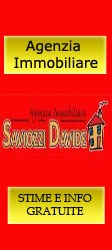
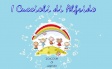









 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO