
Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.
Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.



Il primo fu il .....










-
BOBINA DI TESLA IN AGRIFIERA 2.000.000 di Volt [1]
-
Ma che banda! [3]
-
L'Annunziata (Lucia) ha detto una frase che credo superi qualsiasi caxxata lei abbia mai pronunciato [2]
-
Oggi e i colori. [2]
-
25 aprile 2025 [3]
-
ANCHE A PASQUA SI APRONO GLI STADI. SI GIOCA ANCHE LA SERA DEL SABATO SANTO E LEGGETE LA CITTA' CHE GIOCA [4]
-
Pensieri. [2]


di Valdo Mori











Ma è inevitabile
Chiudo gli occhi per non guardare
Ma quella livida rigidità
appare scompare riappare
Io ti .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
Agrifiera 2025 inaugurata: il programma del 24 e 25 aprile [672]
-
Successo nazionale per il libro di Alessandra Favati, "Il coraggio tra i fiori di ortica" [287]
-
In seconda categoria Il Migliarino/Vecchiano ai play off. Domenica 27 ore 16,00 in casa vs San Vitale Candia [153]
-
L'Annunziata (Lucia) ha detto una frase che credo superi qualsiasi caxxata lei abbia mai pronunciato [149]
-
ATTIVATO IL SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO PER AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA FIERA [134]
-
Ma che banda! [131]
-
Agrifiera 2025 è qui! Vi aspettiamo dal 23 aprile al 4 maggio [128]
-
Petalo bianco-L’illusione degli anti Meloni di acchiappare voti con un partitino cattolico [121]
-
In programma anche la tradizionale biciclettata per le alunne e gli alunni della scuola media [121]
-
Oggi e i colori. [120]
-
Daniela Bertini in scena con ‘DIVISA’, tratto dal romanzo di Piero Iannello [105]
-
Transizione ecologica non vuol dire devastazione del territorio. [104]
-
Liberazione: le celebrazioni a San Giuliano Terme [104]
-
Massimo Cacciari attacca Elly Schlein: " Il 25 Aprile? La sinistra di ogginon ha nulla a che vedere con la Resistenza" [103]
-
Insediamento nuovo parroco parrocchia San Frediano in vecchiano [100]
Libertà religiosa/laicità et et oppure aut aut? Una riflessione di diritto costituzionale, di Stefano Ceccanti
Mi baso soprattutto dalle riflessioni del Manuale di Salvatore Curreri
https://www.ibs.it/lezioni-sui-diritti-fondamentali-libro-salvatore-curreri/e/9788835149552?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwe2_BhBEEiwAM1I7seMJSt3r5TVc_o9RehmcNlvHpDmP01jwjM_INWwgL83KWgxfp8YdIRoC6joQAvD_BwE
che identifica le nozioni condivise in ambito giuridico di libertà religiosa e laicità e che ci descrive quindi bene i casi di et et (laicità aperta con separazione amichevole) aut aut (laicità protetta con separazione ostile) oltre che di rigetto di entrambe (confessionalismo), i modelli che avevo identificato nel mio testo del 2001, che sono tipi ideali e descrivono sinteticamente processi storici di lungo periodo, leggibile qui:
Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi, società multietniche, Il Mulino, Bologna, 2001.http://bit.ly/3r3Xbyw
Importante anche la riflessione di Augusto Barbera che trovate qui
https://www.ibs.it/laicita-alle-radici-dell-occidente-libro-augusto-barbera/e/9788815386748?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwe2_BhBEEiwAM1I7se9YEBEehlQbwnDUuGEuX0CgQkbH6KUgs0Njr0JrqmmKp0a-BDR2_RoCVbIQAvD_BwE
1- Libertà religiosa dall’intolleranza alla tolleranza alla libertà vera e propria
La libertà religiosa è la prima libertà collettiva che si afferma progressivamente negli Stati liberali occidentali, prima in forma limitata come tolleranza e poi come libertà in senso pieno.
Ciò non vuol dire che di norma tutti i culti fossero considerati eguali. Vi era di norma un culto ufficiale a fronte del quale altri erano semplicemente ammessi, tollerati. La tolleranza è una fase di passaggio dall’intolleranza verso la piena libertà, la quale che comporta anche la possibilità di proselitismo verso i credenti della confessione maggioritaria.
2- Laicità: le varie separazioni possibili
Più complicati perché più articolati sono i significati del termine laicità che si dipartono tutti da un’acquisita distinzione tra temporale e spirituale e, quindi, da una separazione istituzionale tra istituzioni pubbliche e delle confessioni religiose, superando i modelli confessionalistici in cui le due realtà erano ancora fuse o comunque confuse.
Si tratta di modelli che, come sostiene Bauberot, creano un equilibrio dinamico tra tre lati di un triangolo: libertà dei singoli e dei gruppi, eguaglianza che tende a garantire livelli di libertà comparabili agli altri anche alle confessioni minoritarie (ad esempio nel proselitismo e sulla tutela penale), separazione istituzionale (anche se, essendo le religioni nella società, la separazione non esclude forme di coordinamento e può sempre con intenti diversi, amichevoli o ostili)
Possiamo parlare di due modelli di fondo:
A) Quello dominante in Occidente di laicità positiva e inclusiva (per addizione, basato sull’ et et tra libertà religiosa e laicità): la laicità è un metodo che consente il confronto tra credenti e non credenti senza fondamentalismi e chiusure dogmatiche ma, al contrario, nel mutuo rispetto e nella reciproca comprensione (Barbera).
Le religioni non rinunciano a rivendicare i propri “valori” ma non l’impongono a tutti perché riconosciute portatrici di visioni parziali della verità”. Di contro, le istituzioni riconoscono ai credenti il diritto di partecipare come tali e di confrontarsi e negoziare con gli altri nella sfera pubblica.
Il modello si concretizza di solito anche in accordi bilaterali (concordati, intese, convenzioni) e riconosce anche forme di obiezione di coscienza a tutela della libertà religiosa.
In tale modello rientra anche l’Italia, come precisato da un’ampia giurisprudenza della Corte costituzionale.
B) Quello minoritario di laicità “protetta” (Barbera) intesa in senso esclusivo e negativo (per sottrazione, aut aut), come rigida neutralità delle istituzioni pubbliche rispetto al fenomeno religioso, da cui lo spazio pubblico deve restare immune perché fattore di potenziale conflitto sociale sia tra credenti che tra questi ultimi e gli atei. Lo Stato deve garantire a tutti libertà di religione, senza ingerenze, ma questa deve rimanere un “affare privato”, privo di rilievo giuridico esterno.
E’ il modello tipico del caso francese, anche se in taluni ambiti il sistema ha ridotto la sua carica di separazione ostile (ad es. il sistema scolastico pubblico plurale dagli anni ‘ 50). Il modello tende a precludere forme pattizie di intesa ed è ostile ai simboli religiosi nello spazio pubblico.
3. Qualche osservazione sul caso italiano: la transizione verso la laicità aperta con Chiesa cattolica, confessioni con intesa, confessioni senza intesa e legge generale
La Costituzione inserì forti elementi di discontinuità rispetto al regime fascista che si basava su principi opposti (confessionalisti che rifiutavano sia la libertà religiosa sia la laicità) prevedendo la libertà religiosa (art. 19) e non una semplice tolleranza e l’estensione del metodo pattizio anche a confessioni diverse dalla cattolica (art. 8). Per quanto l’art. 7 creasse poi un sistema aperto perché era costituzionalizzato solo il metodo pattizio tra Stato e Chiesa, sul momento, per necessità storica, per la volontà di agganciare la Chiesa alla democrazia, fu congelato il Concordato del 1929 che era intriso di confessionalismo.
Per questo la Corte, sintetizzando poi i principi in materia presenti nel testo costituzionale, ha costruito la laicità come “principio supremo”, pur non espressamente scritto nel testo come tale che caratterizza “in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse”. Tale principio sintetizza così la tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2); il divieto di discriminazioni per motivi religiosi (art. 3); la reciproca indipendenza tra ordine temporale ed ordine spirituale (art. 7), l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8), la libertà di religione (art. 19) e il divieto di limitazioni legislative o di gravami fiscali per gli enti religiosi (art. 20),
Sono quindi convissute in modo contraddittorio sino al 1984 (revisione del Concordato e varo delle prime Intese) sia le novità costituzionali di libertà religiosa e laicità sia i residui del confessionalismo precedente, progressivamente smantellate (ad es. con la giurisprudenza costituzionale che in nome di “principi supremi” riduceva la portata di norme concordatarie ad esempio sugli effetti civili delle nullità matrimoniali cattoliche che all’epoca non rispettavano alcune caratteristiche fondamentali o rimuovendo la pretesa che lo Stato non potesse autonomamente decidere sulla dissolubilità del matrimonio civile).
Restano alcuni interrogativi sulla coerenza col sistema costituzionale e con la società contemporanea di alcune limitate scelte operate anche nel 1984, come lo status dell’insegnamento della religione cattolica, confessionale anche se non più obbligatorio.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non sono obbligate a stipulare un’intesa con lo Stato. Le intese, infatti, servono ad adattare il diritto alle specifiche confessioni religiose e non certo a discriminarle tra loro, come talora alcune leggi, specie regionali, hanno tentato di fare, venendo poi bocciate dalla Corte costituzionale. Il modello si è rivelato aperto, tale da comprendere anche nuove presenze religiose non giudaico-cristiane, come buddisti e induisti. Resta scoperta, più per ragioni politiche che non tecniche, legate ai conflitti sull’immigrazione, l’esigenza di un’intesa con l’Islam.
I culti religiosi privi d’intese sono soggetti alle Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi (l. 1159/1929) e al relativo regolamento di esecuzione (r.d. 289/1930), normative amputate dalla Corte costituzionali nelle loro parti più discriminatorie. Resta quindi il problema di varare in positivo una legge generale sulla libertà religiosa, che potrebbe mandare a regime alcune delle novità previste nelle Intese per le confessioni che le hanno ottenute. La legge è stata sin qui impedita da forme di massimalismo giuridico che pretendevano di stabilire in modo astratto e univoco le nozioni di libertà religiosa e di laicità prima di passare al riconoscimento di diritti e doveri specifici. Essendo difficile approvare una legge generale per resistenze varie, le principali confessioni religiose (Islam escluso) hanno infatti preferito usare le Intese non solo e non tanto per le esigenze specifiche della loro confessione (a cui sarebbe destinato quello strumento) ma per risolvere problemi di tutti. Infatti le Intese sono quasi tutte e quasi per intero redatte secondo uno schema fotocopia. Per questo sarebbe relativamente semplice approvare una legge generale che mandasse a regime per tutti buona parte di quelle norme.
Infine va segnalato che, oltreché la libertà positiva di credere, la Costituzione, attraverso l’art. 19, tutela anche quella negativa di non credere e, quindi, di essere atei. Di conseguenza, in negativo “il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione [non può] essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie dello Stato” (C. cost. 334/1996, 3.1); in positivo, è legittima la propaganda dell’ateismo purché non scada nella denigrazione dei credenti (Cass., I civ. 7893/2020).
Dalla libertà negativa di religione si sono tratti diversi diritti, in relazione alle molteplici situazioni in cui anche il non credente non deve essere costretto a comportamenti contrari alla sua coscienza.
Incontro 28 aprile 2025 | ex msac




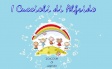




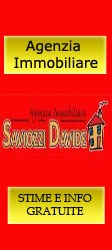


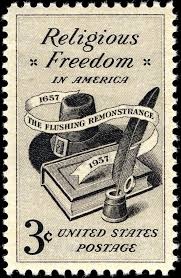
 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO